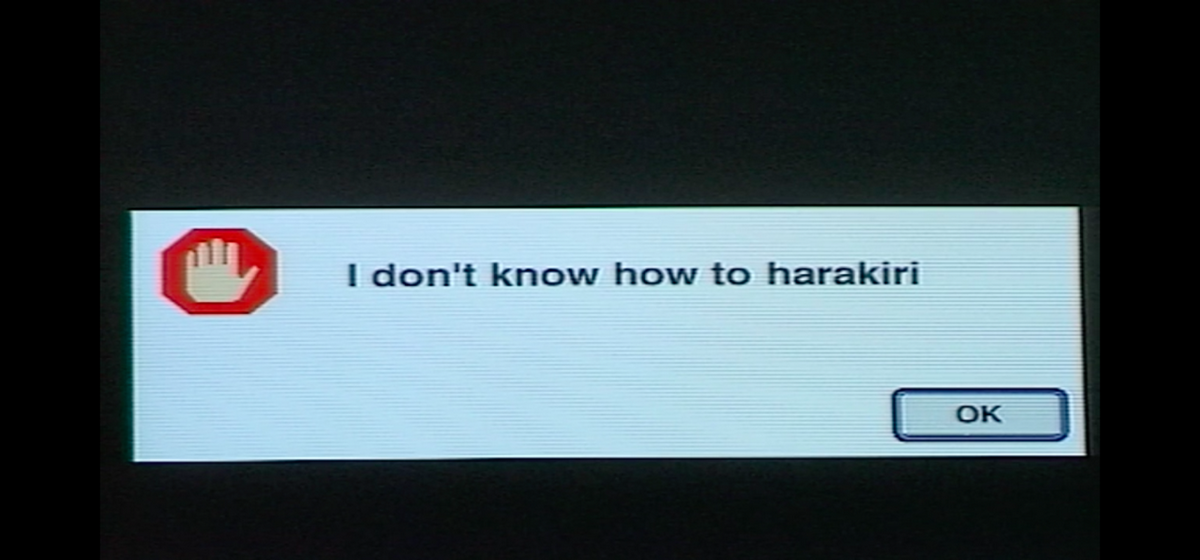Speciale MUBI - Lo straniero
L'ultimo film del grande regista indiano Satyajit Ray, summa e assieme messa in discussione di un'intera carriera attraverso un racconto su come non essere un "kupa-munduk".

[Questo articolo fa parte di uno Speciale dedicato alla piattaforma di streaming on demand MUBI, un focus monografico composta da una galleria di recensioni contaminate da riflessioni teoriche, emotive, autobiografiche, per riflettere trasversalmente sul tema della cinefilia on demand e sul più generale rapporto che intessiamo oggi con le immagini. Il progetto è stato presentato e inquadrato nell'editoriale "Di MUBI e del nome del cinema", che potete trovare qui].
Ecco, probabilmente ci ho messo molto più di quanto avrei dovuto a parlare di questo film, in quest’anno folle e strano, in cui son trascorsi mesi angoscianti tra bollettini di morte e messaggi apocalittici e infine una ripartenza faticosa, non meno ricca di paure e paranoie costanti. Eppure si va avanti, il tempo scorre, anzi no, il tempo corre. E correndo sembra che arrivino nuovi lavori, nuovi set, nuove persone, nuovi film, nuove visioni. Tuttavia, in questi giorni di primo vero freddo, con la pioggia che batte sulle lamiere dei mercati rionali di Roma, il cielo grigio e poca gente per strada, in cui le statistiche sembrano predire un altro (santi numi) disastroso Lockdown, è salvifico ripensare alle visioni private di quest’anno e tenere le dita incrociate affinché le cose si assestino e si possa tornare a fare e vedere cinema, senza le angustie e le ansie del mostro Covid in agguato. Tra queste visioni, nelle offerte della preziosa Videoteca di MUBI, ci sono diversi film di uno dei più grandi registi indiani: Satyajit Ray.
Con Lo straniero (Agantuk), nel 1991, Ray firma il suo ultimo film (curiosamente prodotto da Gerard Depardieu), chiudendo una carriera cinematografica di tutto rispetto e una vita (Ray muore poco dopo) di grandi fatiche e grandi soddisfazioni.
Lo straniero è una conferma dello stile dell’“ultimo” Ray: i personaggi si muovono in ambienti circoscritti, i dialoghi si fanno sempre più serrati al punto da scavalcare l’immagine, le inquadrature tradiscono la fatica fisica del regista a muoversi agilmente seguendo i corpi davanti la macchina da presa. Siamo ben lontani dai commoventi riflessi de Il lamento sul sentiero (Pather Panchali, 1955), dalle delicate dissolvenze del magnifico La moglie sola (Charulata – 1964) e dalla composizione pittorica de La sala della musica (Jalsaghar – 1958). In Agantuk, come negli ultimi film di Ray (Nemico pubblico, La casa e il mondo), il nodo centrale e il cuore pulsante del film risiede nel voler sbrogliare un problema identitario relativo al popolo indiano, oltre alla volontà evidente del regista di operare un’autocritica alla rappresentazione (da lui stesso operata) di una certa classe sociale indiana.
La prima inquadratura è emblematica in tal senso: le mani di Anila sorreggono una lettera arrivata da Nuova Delhi in cui suo zio, Manmohan Mitra, annuncia la sua imminente visita. Quest’uomo ha lasciato l’India trentacinque anni prima, quando Anila di anni ne aveva solo due, al fine di intraprendere viaggi per il mondo. La lettera «elegante e ben scritta» getta nel caos la famiglia Bose: Anila, suo marito Sudhindra e il figlioletto Satyaki non conoscendo quest’uomo, si trovano ad affrontare un dilemma: Manmohan Mitra è davvero il ritrovato zio, oppure è un impostore venuto per rivendicare una parte di eredità familiare?
Essendo un ospite, la famiglia vuol riservare al presunto zio la giusta e proverbiale ospitalità bhadralok (che letteralmente vuol dire proprio “persona di buone maniere” e si riferisce alla classe sociale nata in Bengala durante il periodo coloniale britannico, dal 1757 al 1947) ma i singoli componenti, in maniere differenti, nutrono dubbi sull’identità dello straniero antropologo che si è presentato in casa loro, rompendo l’armonioso equilibrio familiare.

«To be or not to be the uncle» afferma lo stesso Mahmohan Mitra: i suoi racconti, i suoi viaggi per il mondo, tutta la stratificazione vitale del personaggio è completamente messa in discussione, al punto che qualsiasi cosa potrebbe essere frutto di pura congettura, di trama ordita al fine di estorcere danaro a questa famiglia indiana “perbene”. È tutta una questione di fede, dunque. Non a caso, l’unico a credere che lo straniero sia realmente chi dice di essere è il piccolo Satyaki, il cui nome ci rivela, all’istante, la futura complicità dei due personaggi. Satyaki, come sottolineato dallo zio, è il nome di uno dei più fedeli discepoli di Krishna. Il bambino rappresenta per Ray la purezza della fede, oramai smarrita dall’atrofizzata classe bhadralok, i cui principi di civilizzazione hanno finito per distruggere la civiltà indiana, intesa come insieme di tradizioni e usi ancestrali.
In Agantuk il processo della riappropriazione di sé sta nella conoscenza dell’altro, lasciando dunque il centro per andare ai margini. Questa conoscenza è imprescindibile dal linguaggio: Manmohan Mitra, quando incontra per la prima volta Satyaki, gli dice che gli insegnerà «tutti e centootto i nomi di Krishna» e la ricca tradizione della mitologia che gli occidentalizzati indiani hanno dimenticato o abbandonato. Manmohan Mitra non vuole che Satyaki cresca come un kupa-munduk, ossia una rana che vive esclusivamente in un pozzo: finché la rana non lascia il pozzo, dal quale osserva sempre lo stesso frammento di cielo, essa è convinta che quella sia l’unica realtà possibile.
Appare tuttavia chiara e inequivocabile la posizione di Ray, che pone una sfida a sé stesso attraverso un processo di auto-trascendenza e negazione di sé, creando il personaggio di un antropologo che rifiuta e distrugge progressivamente il concetto bhadralok di civiltà, protagonista indiscussa di buona parte della filmografia dello stesso regista. Per Manmohan Mitra la civiltà moderna è piena di malcontento. Tutto il suo presunto stile di vita, il modo in cui ha rinunciato a una promettente carriera accademica per mettersi in gioco a modo suo, è una testimonianza vivente della sua fede. E, sebbene in lui ci sia una maledetta stanchezza, sembra ancora più profondamente, misteriosamente contento di chiunque altro nel film. «Il mio più grande rimpianto è di non poter essere un selvaggio, poiché ho Shakespeare, Marx e Freud nelle mie vene» afferma Mitra. Il personaggio dello zio è magico, appartiene a un’altra dimensione: egli stesso dichiara che il suo soprannome è Nemo, che in latino vuol dire Nessuno, No-one e, mentre l’obiettivo della famiglia Bose è stabilire che egli sia Qualcuno, Some-one; il suo compito è quello di riconnettere la famiglia bhadralok alle sue tradizioni, alle sue radici. Un compito arduo, che richiede sofferenza e una buona dose di indignazione ma che alla fine si concretizza poiché lo straniero, con delicatezza, porta tutti i personaggi a una profonda riflessione auto-esaminante.
Nella magnifica ed emozionante danza tribale finale, in cui Anila, sua nipote, comincia a ballare con altre donne di un villaggio indiano, il film si apre finalmente a un momento musicale (tipico dello stile di Ray) e tutti sono felici e sorridenti: la riconnessione è avvenuta. E lo zio Nemo che ha terminato il suo compito, come Ulisse, mosso dall’instancabile sete di conoscenza, può ripartire alla volta di altre avventure, alla scoperta di altre civiltà, di altre lingue, rifiutandosi categoricamente di essere un kupa-munduk, ricordandoci che in quanto esseri viventi di questo mondo siamo tutti connessi.