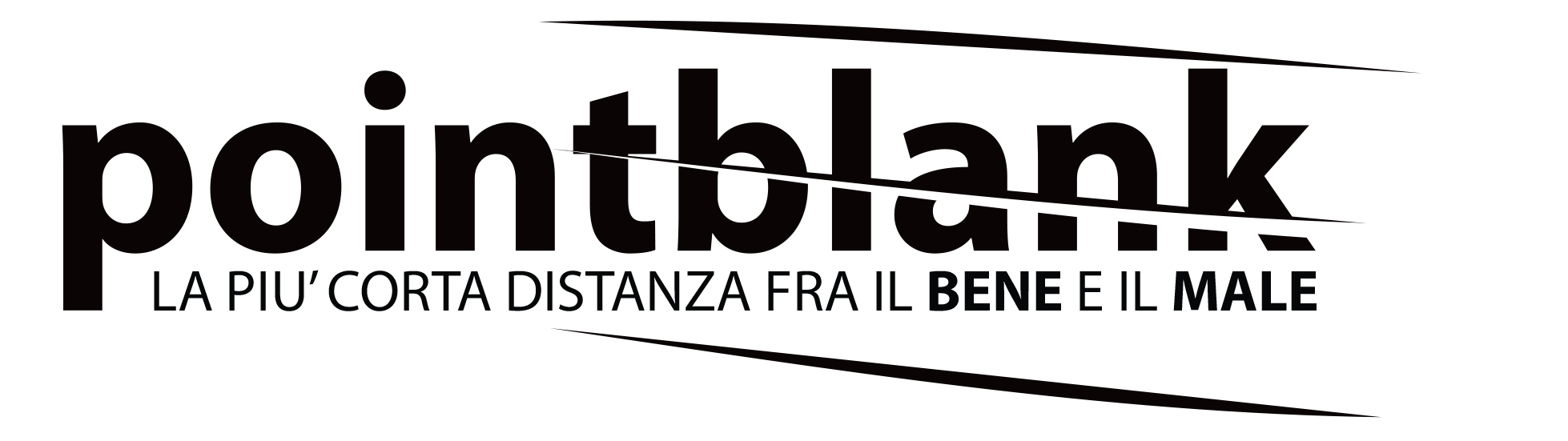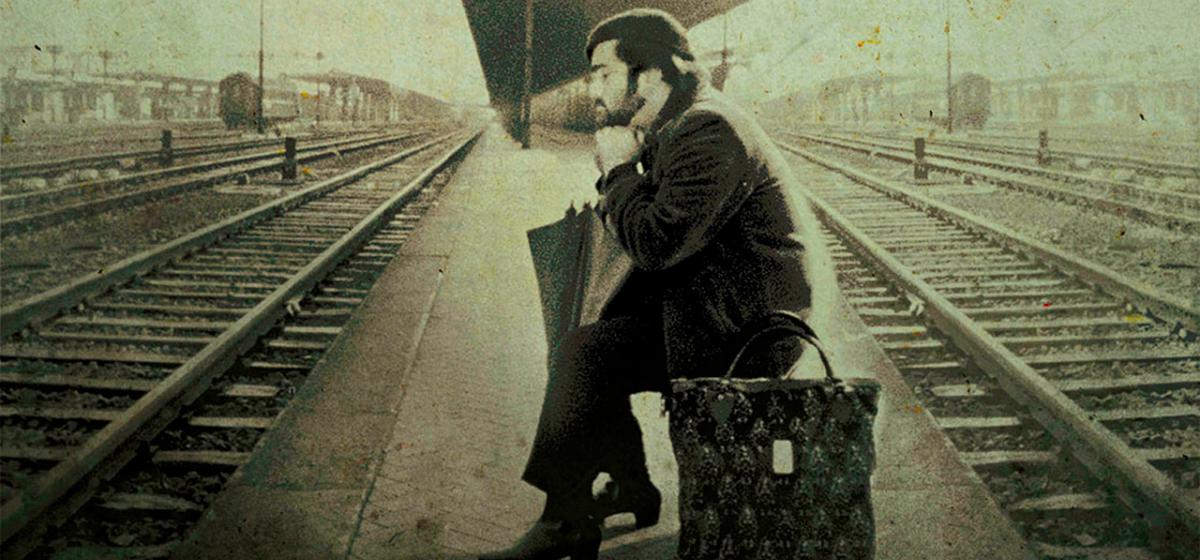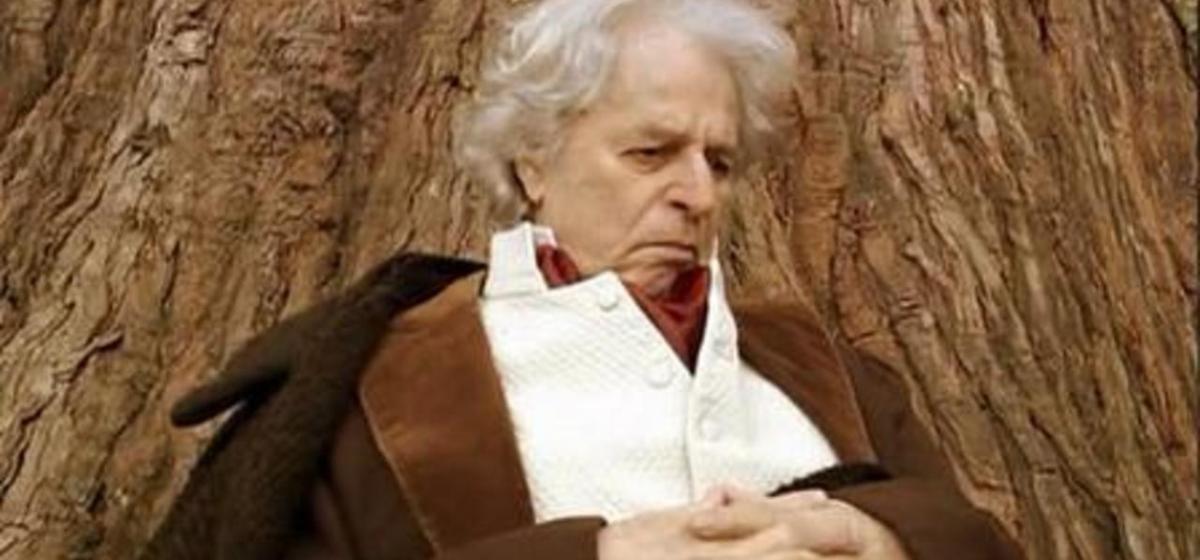Il potere
La genesi del potere, nel capolavoro linguistico ed intellettuale di Augusto Tretti, outsider fuori dagli sche(r)mi

Il potere (1971) è l’opera più nota dell’esigua filmografia del regista veronese Augusto Tretti. Mai sentito nominare? Probabilmente solo a margine di studi accademici di settore ( e non è neppure detto!) oppure tra gli amanti del cinema outsider. Si aggiunga che non poteva che vacillare nell’oblio ufficiale un film anticonvenzionale nel linguaggio e programmaticamente volto a puntare il dito contro il re nudo, qui in Italia dove vige la rimozione d’ufficio di spine nel fianco intellettuale, o meglio dei pungoli della coscienza sociopolitica popolare, che è sempre stato bene stordire nel panem et circenses.
A voler spulciare nelle note di un manuale di storia del cinema, lo si troverà annoverato tra i numerosissimi esordi dei primi anni ‘60 e nello specifico tra coloro che “un po’ registi per caso”, dovettero la propria fortuna in parte all’arbitrio incondizionato di certi produttori, su tutti Goffredo Lombardo, proprio colui che insperatamente avviò le riprese del “Potere”, per poi doversene ritrarre, preda del collasso economico della Titanus. Travagliato nella lavorazione, durata ben sette anni, Il potere venne presentato alla Mostra del cinema di Venezia, rivelandosi sin da subito una mina vagante, da disinnescare (come avvenne per censura e opposizione) o da lasciar esplodere in tutto il suo potenziale, come auspicavano certi autorevoli estimatori, quali furono Fellini, Antonioni, Moravia, Fortini, Zavattini, Flaiano. Tretti realizzò un capolavoro di rigorosa dissacrazione del sistema istituzionale (il medesimo già oggetto del suo precedente film, La legge della tromba, in cui allegorico sentenziava “è il sistema che non funziona!”). Partendo dalla parodia dell’industria cinematografica meramente di consumo, punta d’iceberg, discendeva le fondamenta del determinismo politico-economico sotteso, attraverso una disarmante semplicità di pensiero e voluta miseria di artifizi scenici ed interpretativi, che solo ai detrattori malignamente ingenui parve il caso di additare come anacronismo e dilettantismo.
La provocazione formale trovava inoltre vera e propria dinamite nel genere comico – grottesco, con cui Tretti inscenava questa strampalata eppure lucida ricostruzione della Storia umana, in cui i capitoli dell’evoluzione della civiltà, dalla preistoria all’età contemporanea, venivano scritti dalle convenienze e dalle connivenze di tre avide fiere antropomorfe, sedute su seggi regali a rappresentare i poteri militare, economico e agrario. Il primo quadro, calato all’età della pietra, si pone in parte come chiave dell’intera narrazione, che molto si dilungherà sulla parabola enfatizzata del regime fascista, a sancire come questo gioco di conservazione dei poteri forti, a scapito dei movimenti di emancipazione sociale, non possa che leggersi come una farsa cosmogonica, andata mitizzandosi e perpetrandosi nel corso dei secoli sul terreno fertile della repressione e dell’ignoranza di massa. Sulle trombe squillanti dei titoli di testa, i tre scanni sono vuoti, il potere costituito ancora non esiste quando i cavernicoli trettiani (attori non professionisti dalle parrucche posticce) si barcamenano nella caccia di una gallina. Solo quando un fulmine caduto al suolo sprigionerà il fuoco, l’umanità traccerà la demarcazione antropologica tra oppressi ed oppressori a seconda della reazione mostrata dinanzi all’ignoto: se i primi si daranno ragione del creato immaginando l’Olimpo, i secondi escogiteranno la retorica per soggiogare l’immaginazione stessa. Ecco data la genesi viziosa del potere primordiale, vaso di pandora, che da Oriente ad Occidente, dalla notte dei tempi ad oggi, trova legittimità nel fondamentalismo del dogma di fede: “Guai a voi se mangerete la carne”, “Guai a voi se mangerete la carne di venerdì!”, “Guai a voi se userete la pillola!”.
Augusto Tretti, già dagli esordi riconosciuto magistrale epigono dell’effetto straniante di matrice brechtiana, inanella ellissi di montaggio (emblematici gli inserti documentaristici e cinegiornali) innestate nell’assetto comico di sceneggiatura, che non possono non trascinare lo spettatore, anche quello più sprovveduto, a ponderare nel paradosso quanto vede, piuttosto che ad immedesimarvici dentro, irretito nelle maglie subliminali dell’autorità di turno, che veicola per lui stili di vita (apoteosi nell’epilogo del Moblon – moloch del regime consumistico, che magnetizza le coscienze, o come profetizzava Pasolini, le deforma irrimediabilmente). Così nel quadro dell’Impero Romano, assodata l’ascendenza divina, le maschere del potere militare, commerciale ed agrario prendono piene funzioni e di epoca in epoca tireranno e recideranno le fila di burattini, perché tutto cambi restando immutato, perché non giunga mai l’apocalisse, ovvero il giorno in cui gli uomini travolti dalla Storia squarceranno “il cielo di carta”, dubitando di se stessi. Il siero critico iniettato dall’inedito cinema di Tretti si palesa forse ancora pericolosamente rivoluzionario per poter farsi largo e dunque, stroncato sul nascere, questo genio nostrano offuscato, ma sotto gli occhi di tutti, aleggia oggi come un spettro nel limbo dei pensatori precursori dei tempi che chissà mai verranno prima o poi, prima o dopo YouTube dove Tretti, mai distribuito da vivo, è eternamente rimesso al mondo.