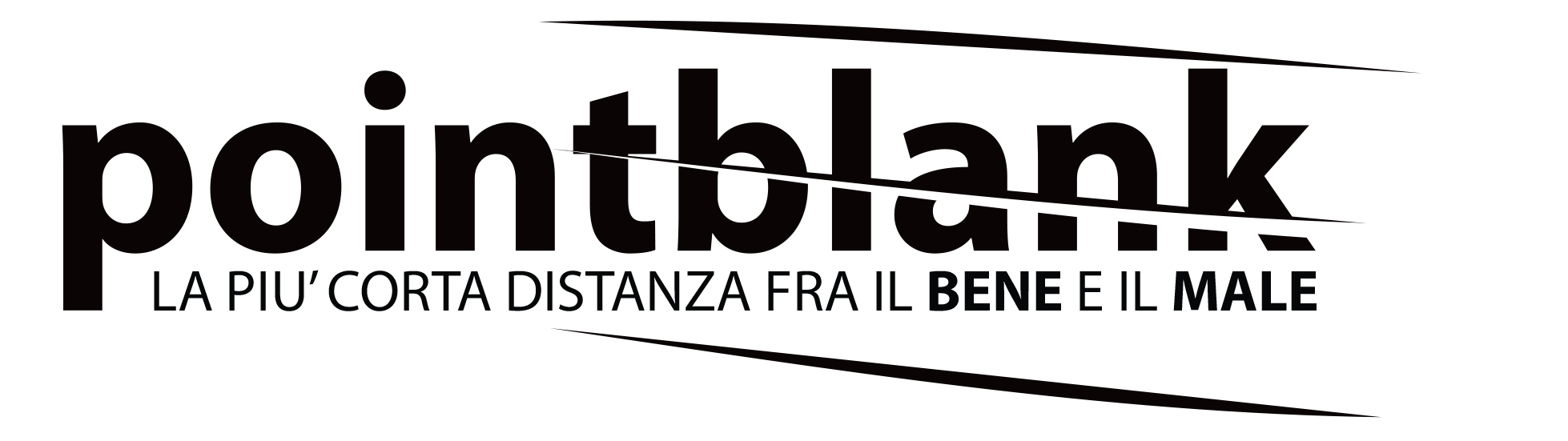Line of Duty
Dal secondo canale della tv pubblica inglese, una serie poliziesca che fa dell'ambiguità e dell'indagine etica le sue armi migliori, dedicata com'è al mondo della corruzione e dell'abuso di potere.

Line of Duty è un procedural-drama della BBC2; anzi, IL procedural-drama, considerato che si tratta della serie drammatica del secondo canale televisivo del servizio pubblico britannico più vista nell’era multichannel (ossia degli ultimi 15 anni, da quando è cambiato il metodo di rilevazione dei dati di ascolto), con circa 5 milioni di spettatori a puntata. Pur essendosi aggiudicata il Freesat Award e il Royal Television Society Award come miglior serie drammatica ed avendo ottenuto svariate nomination ai più importanti premi della tv britannica (dai Bafta ai Crime Thriller Award), la serie è praticamente sconosciuta in Italia, dove non è mai stata distribuita. Eppure stiamo parlando di un prodotto che il Telegraph ha inserito nella classifica dei migliori show della BBC2 di tutti i tempi, e che l’Independent ha giudicato tra le prime dieci serie poliziesche migliori di sempre (davanti a prodotti ben più blasonati come The Shield e Law & Order, e subito dietro a pietre miliari del genere come The Wire e Hill Street Blues).
Line of Duty racconta le indagini dell’Unità Anti-Crimine della polizia di Birmingham (dove è stata girata la prima stagione, mentre la seconda e la terza hanno avuto come location Belfast), anche se la città non viene mai espressamente nominata nel corso della serie; parla di sbirri che indagano sugli sbirri (quelli che negli Stati Uniti vengono asetticamente chiamati, non senza un certo disprezzo, “gli Affari Interni”): quelli che, di solito, vengono descritti come burocrati ficcanaso, funzionari frustrati e agenti mancati; quelli che non hanno il coraggio di sporcarsi le mani sul campo, dove c’è l’azione vera, e che preferiscono invece fare le pulci ai colleghi più “impavidi” che rischiano la pelle per cercare di assicurare alla giustizia i cattivoni di turno. In buona sostanza, la serie racconta le gesta di quelli che, nelle serie poliziesche tradizionali, assumono il ruolo di antagonisti o, tutt’al più, di meri bastoni tra le ruote.
Nello show creato e scritto da Jed Mercurio, invece, i membri della squadra anticorruzione britannica diventano, per una volta, i veri protagonisti della vicenda; con il loro talento e il loro mestiere si prodigano per smascherare il marcio, le frodi e la corruzione dei loro disonesti colleghi. Perché lo sporco non è solo “sul campo”, ma anche dentro gli uffici, i commissariati e i distretti di polizia; e impedire che quello sporco finisca nascosto sotto qualche capiente tappeto sarà la missione dei detective Arnott, Fleming e Hastings (ottimamente interpretati da Martin Comston, Vicky McClure e Adrian Dunbar). Ovviamente, trattandosi di una serie inglese a forte tinte drammatiche, la polizia ne esce malissimo! Basti pensare che per raggiungere il massimo livello di realismo e attendibilità il team di scrittori si è avvalso delle competenze e dell’esperienza di ex poliziotti, consulenti anonimi e gole profonde, visto che la polizia si era rifiutata categoricamente di collaborare in qualunque modo al progetto.
La serie punta tutto sulla credibilità delle vicende narrate e non cerca mai di diventare rassicurante. La polizia è descritta come un organismo sfaccettato e vario, composto di agenti onesti e di loro colleghi che invece sfruttano la posizione per ragioni personali o di servizio. Gli autori non fanno sconti a nessuno e quello che viene mostrato sullo schermo è il frutto di un importante lavoro di ricerca e documentazione che, se non vero al cento per cento, è quantomeno assai plausibile. La serie è stata addirittura condannata dall’Ofcom (l\'autorità competente e regolatrice indipendente per le società di comunicazione nel Regno Unito) per aver fatto recitare ad un attore di 13 anni (Gregory Piper) scene crudissime e di estrema violenza, al punto che a supporto gli è stato addirittura imposto l’affiancamento di uno psicologo, onde evitare che potesse rimanere segnato e turbato più del dovuto.
Line of Duty, quanto a linguaggio visivo e narrativo, è assolutamente classica: non ci sono gli sperimentalismi cromatici di Utopia né i virtuosistici movimenti di camera di True Detective, come mancano le trovate di regia e di sceneggiatura cui ci hanno abituato prodotti come Mr. Robot e The Affair (per rimanere in un ambito in qualche modo inerente al crime). Tuttavia la cura formale della serie è magistrale, arricchita da un attenzione per la scrittura che insieme hanno pochi eguali nel raffinato universo delle produzioni britanniche. La regia è asciutta, spietata, implacabile e sempre, in qualche modo, distante dai propri personaggi. Il registro visivo, infatti, è caratterizzato da un gelido distacco, favorito dalla consapevole rinuncia ai codici e agli artifici presenti nella maggior parte degli show che hanno per protagonisti investigatori e agenti di polizia (ad esempio, in Line of Duty è praticamente assente l’uso della macchina a spalla, che, probabilmente, avvicinerebbe troppo lo spettatore, portandolo allo stesso livello dei personaggi e creando una compartecipazione emotiva evidentemente non gradita agli autori). Al contrario, la macchina da presa è sempre un corpo estraneo – seppur vicinissimo – all’azione; è un occhio che osserva e indaga impietosamente i personaggi e il loro mondo, di cui analizza ed espone ogni dettaglio: dal vestito spiegazzato e poco cool alla scrivania disordinata; dalle tappezzerie polverose dei flat popolari alle grigie e malinconiche strade della periferia inglese. Uno sguardo costantemente sul collo dei protagonisti, ma mai al loro fianco. Nessuna casualità di ripresa, dunque. Nessuna voglia di far immedesimare lo spettatore nelle vicende osservate. Il pubblico deve guardare e analizzare quello che avviene sullo schermo mantenendo la lucidità che solo una certa terzietà può consentire. Ovvio che si tifa per i buoni, ma noi spettatori non siamo loro.
La ricerca di questa fredda autenticità si riflette nel rifiuto ad utilizzare un linguaggio di tipo amatoriale, una poetica iperrealista che, come detto, è assai tipica del genere. Anche le pur bellissime sequenze action (in particolare l’inseguimento che chiude l’ultima puntata della terza stagione) sono un gioiello di montaggio in cui il dinamismo dell’azione viene restituito non dalla solita macchina a spalla che corre dietro ai protagonisti, ma da uno sguardo immobile e fisso che, da diversi angoli, vede tutto e registra tutto. Non stiamo assistendo ad un reportage ma ad un prodotto intellettuale consapevole e ragionato. La realtà non viene trovata e scoperta assieme agli autori (The Jinx, almeno in apparenza, o l’antologica American Crime) bensì raccontata e spiegata al pubblico attraverso l’uso sapiente di immagini statiche, inquadrature formalmente elaborate e, addirittura, eleganti. Il tutto supportato da grandi sceneggiature di genere, prive di dettagli abbozzati o fuori posto e nelle quali ogni sequenza è in grado di generare tensione attraverso poche linee di dialogo, senza mai rinunciare per questo al coinvolgimento emotivo (esemplare a riguardo la puntata della terza stagione dedicata integralmente ad un lungo, sfiancante interrogatorio).
Come dicevamo, questo impianto narrativo e registico è assolutamente funzionale a mantenere vigile l’attenzione del pubblico, il quale, prima ancora di partecipare emotivamente alla vicenda, deve sforzarsi di capirne la complessità e le sfumature. Questo perché la serie vuole essere un continuo gioco di ombre e luci: il Bene e il Male sono due mondi che si intersecano e si confondono sempre di più, al punto che la sottile linea che li separa – la line of duty del titolo – diventa un qualcosa che, prima ancora che far rispettare, occorre in qualche modo comprendere e definire. Quanto può essere pericoloso un poliziotto che decide di passare dall’altra parte? E fino a che punto si può aggirare la legge per assicurare alla giustizia un delinquente? Non sono affatto domande retoriche, dal momento che i fatti di cronaca registrano sempre più spesso abusi e reati da parte di chi dovrebbe, invece, servire e proteggere. Il tema è sicuramente arcinoto e inflazionato, ma in questo caso gli interrogativi esistenziali e filosofici si misurano con la vita spiccia e si confrontano non solo con le magagne della burocrazia, con i vizi del sistema e con il senso di intoccabilità di chi sa di poterla fare franca, ma anche con la responsabilità dell’autorità, con la tentazione del giocare sporco per assicurarsi l’esito di una battaglia giusta; con la tentazione di giustificare il mezzo per raggiungere il fine. Ma attenzione: non si tratta di fare del moralismo da quattro soldi. Né di contestarlo a priori. Si tratta di provare a definire il concetto stesso di Giustizia, di Dovere e di Etica (da qui, la distanza registica di cui abbiamo parlato, che costringe lo spettatore a sentirsi sempre un corpo separato ed estraneo ai fatti narrati, che può autonomamente valutare, giudicare, approvare o condannare).