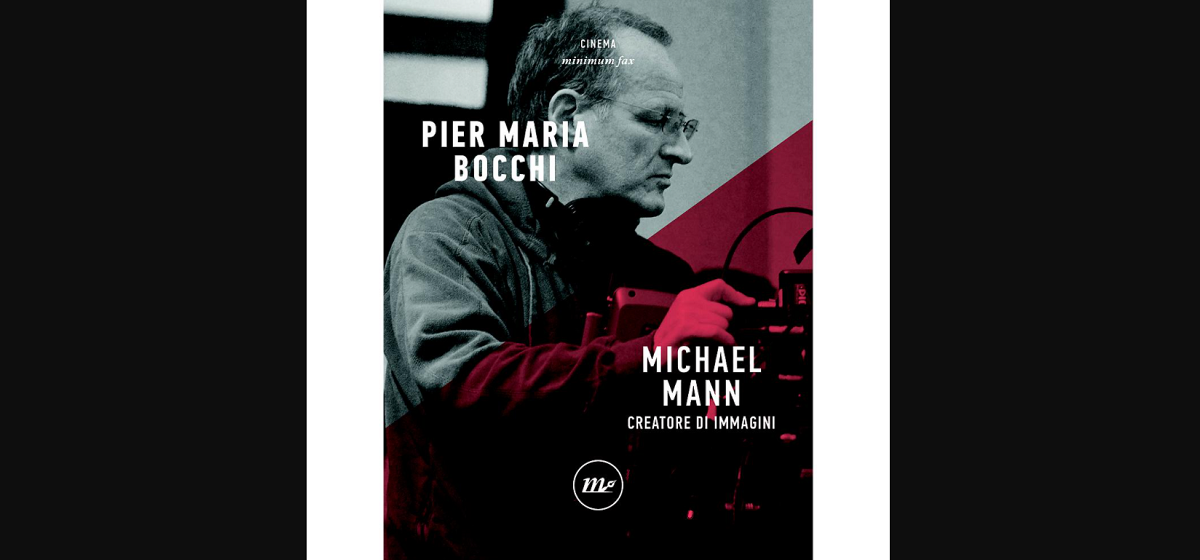“A proposito di niente” di Woody Allen
Tutti i “niente” di Woody Allen: la vita e la morte, la comicità, il cinema e le donne come dannazione e salvezza quotidiana.

Un giorno la scrittrice e maestra del giornalismo americano, Francine du Plessix Gray, andò a intervistare Woody Allen: un incontro che prometteva scintille, sulle colonne del New Yorker per il quale lavorava. Invece, dopo ore di conversazione, la candidata al premio Pulitzer concluse mestamente: «Su Woody Allen non c'è molto da raccontare». A proposito di niente è proprio il titolo della sua autobiografia, scritta a 84 anni e uscita in Italia per La Nave di Teseo, in originale Apropos of Nothing. Autobiography. Ma – qui il primo paradosso – è un “niente” di 400 pagine quello del cineasta americano, di colui che ha segnato almeno due decenni di Storia del cinema ed è ancora in piena attività, visto che il testo si conclude parlando di Rifkin's Festival, il suo prossimo film finito di girare in Spagna.
E allora? Allora per Allen appare evidente fin dalle prime righe che il suo “niente” è un simbolo e una metafora. Da una parte il concetto si applica concretamente: non è una vita avventurosa, come noto, bensì segnata dalla routine e dalle rigide regole di lavoro, che lo hanno portato finora a girare 49 film da regista più una serie e tutti quelli da attore. Ma è anche un “niente” intimo che riguarda la percezione di sé, visto che l'autore non si è mai considerato un genio né intellettuale, ma solo una stella minore rispetto ai suoi maestri come Bergman e Tennessee Williams: «A sentire mia madre avrei dovuto essere capace di spiegare la teoria delle stringhe. Ma lo vedete anche dai film che ho fatto: alcuni sono divertenti, ma nessuna delle mie idee sarà mai la base di una nuova religione». La famosa diminuzione alleniana di sé, tematizzata più volte su pellicola, non è certo una posa poetica e anzi si ricollega direttamente al terzo “niente”, quello che interviene dopo la vita: «Ho sempre pensato che la religione fosse un grande imbroglio», scrive, dopo l'ateismo radicale abbracciato fin da ragazzo, malgrado la fede della famiglia ebraica comunque e sempre amata.
Ma ripartiamo dall'inizio. L'autobiografia di Woody Allen si apre come un film di Woody Allen, forse Radio Days: racconta la sua nascita e l'infanzia, chi erano i suoi genitori, in uno dei noti ritratti famigliari tanto paradossale quanto esilarante. «Mamma aveva cinque sorelle, una più brutta dell’altra – e lei verosimilmente le batteva tutte. Lasciatemelo dire: la teoria freudiana secondo cui noi uomini desideriamo inconsciamente uccidere nostro padre e sposare nostra madre casca miseramente nel caso della mia genitrice». E così inizia un memoir in commedia che si pone tra realtà e invenzione, tra vero e iperbole, tra plausibile e incredibile: il giovane Woody scopre la vocazione comica passando per il fasto luccicante della Hollywood classica. Sì, perché un altro “niente” che percorre il libro è quello che riguarda il cinema: niente di concreto, naturalmente, è “solo” la grande industria dei sogni a cui l'autore dedica alcune delle pagine più toccanti. Lui è come noi: una persona qualsiasi con un'esistenza mediamente normale che entra in una sala cinematografica, si siede e spalanca gli occhi, e così inizia la magia. Da incorniciare il racconto del doppio spettacolo del sabato a mezzogiorno: «Com'era emozionante entrare al Midway il sabato mattina, con le luci ancora accese e una piccola folla che comprava i dolciumi e prendeva posto, mentre i gestori mettevano su dei dischi per evitare ribellioni prima che si spegnessero le luci (…). Alla fine le luci si abbassavano e nello schermo d'argento compariva un logo che faceva venire l'acquolina in bocca al cuore».
Inevitabile che la genesi di Woody sia dentro un cinema, dove si recava con l'amata cugina Rita, in una sorta di seconda nascita dopo quella genetica. I suoi preferiti? Molti e non sempre scontati, da Groucho Marx a Jerry Lewis, ma nello sviluppo della sua predilezione comica l'autore indica un nome preciso: Bob Hope. «Lo adoravo fin da piccolo e ancora oggi non mi stanco mai di rivedere i suoi film (…). Certo, i suoi film sono leggerini e l'umorismo non è quello di George Bernard Shaw, ma lui ha una tale presenza comica e la sua recitazione è stratosferica». Il personaggio più autobiografico? La protagonista de La rosa purpurea del Cairo, Mia Farrow che entra in sala e inizia a fantasticare. E Mia è anche una donna. Perché le donne sono l'altro tema portante del racconto, la magnifica ossessione alleniana: dalle ragazze incontrate in gioventù fino alle fidanzate e mogli, spesso il regista resta in muta contemplazione del mistero femminino, limitandosi a sottolinearne la bellezza e la grandezza. Che è anche cinematografica. Lo dimostra il primo incontro con la giovane Diane Keaton, ovviamente a un provino, un'altra pagina struggente che evade dalla descrizione della singola figura e arriva a sfiorare l'idea dell'attrice come materia dei sogni, creatura mitologica letteralmente illuminante, ovvero che irradia luce e rischiara ciò che ha intorno: «Ci sono personalità che illuminano una stanza. La sua illuminava un viale». Attraverso Diane siamo ancora nella dichiarazione d'amore per il cinema.
A proposito di niente però è anche come Melinda e Melinda: sia commedia che tragedia. Allen affronta la drammatica separazione con Mia Farrow, oggetto di una causa milionaria e soprattutto dell'accusa di molestie sulla figlia adottiva di Mia, Dylan Farrow, lanciata all'epoca e tornata negli ultimi anni, malgrado due indagini finite con il non luogo a procedere. Ecco un altro “niente”, dato che per il regista nulla è avvenuto. Senza entrare nel dettaglio Woody racconta la storia dolorosa naturalmente nella sua versione, ma citando anche la verità giudiziaria, una vicenda che si ricollega invece alla vera luce della sua vita: la moglie Soon-Yi a cui è dedicato il libro, che a intervalli irregolari suona come una continua dichiarazione nei suoi confronti, con l'immenso amore e stima per la donna che passa sempre al setaccio dell'ironia («Pendeva dalle mie labbra e poi mi ha avuto in pugno»). Cosa manca? I film, certamente: Allen resta sempre scettico su di sé e non li spiega nel dettaglio, racconta alcune riprese e rapporti con attori, si dice meravigliato di certi riscontri (non si aspettava il successo di Manhattan e il fallimento di Hollywood Ending), sostiene che La ruota delle meraviglie sia il suo film migliore. Si tiene in disparte da premi e non legge recensioni. Ma sui titoli alleniani, tutto sommato, qui c'è poco da sapere: alcuni cenni e aneddoti, ma è chiaro come il regista non sia la persona più adatta per giudicare. «Il mio rimpianto più grande? Che ho avuto milioni per fare film in totale libertà, e non ho mai girato un capolavoro». E allora Io e Annie o Un'altra donna? Ognuno ci metta il titolo che preferisce. Ma non è questo il motivo per leggere il libro: la ragione sta nel percorso stesso, un viaggio nella mente alleniana altalenante e frastagliato, ispirato ma anche in crisi (come i film dell'ultimo ventennio), geniale ma anche prolisso, con alcuni punti fermi. La morte come fine della vita, che quindi va presa con ironia. Il cinema e le donne come strumenti che ci dannano e salvano quotidianamente. Un paragone possibile? L'autobiografia di Buster Keaton, Memorie a rotta di collo che in inglese si chiama My Wonderful World of Slapstick: il “mondo meraviglioso” sembra il contrario del “niente” alleniano eppure sono la stessa cosa, perché il mondo e il niente sono due nomi che si danno al cinema.