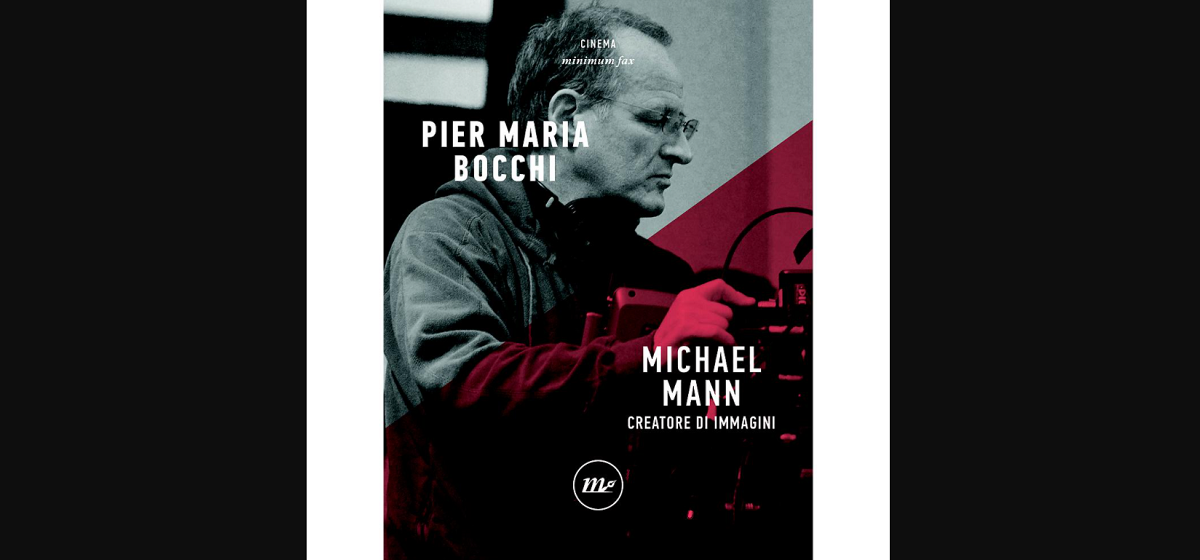Su "Bianco", di Bret Easton Ellis
Riflessioni sul nuovo libro dell’autore di “American Psycho”: nel narcisismo del presente Patrick Bateman è il selfie definitivo.

Da sempre la provocazione fa parte del gesto cine-letterario, è una costola di esso, esiste e basta, in senso non giudicante ma connotativo del termine. Ogni tempo ha i suoi provocatori: lo era a metà Ottocento Charles Baudelaire, costretto a ritirare sei poesie de I fiori del male per oltraggio alla morale pubblica; lo era a metà Novecento Vladimir Nabokov, con il divieto di Lolita imposto per due anni dal governo francese; lo è oggi Michel Houellebecq, che in Sottomissione immagina la vittoria del Partito islamico alle elezioni e in Serotonina racconta un uomo depresso che “sta morendo di tristezza”. Lo è Lars von Trier - piaccia o meno - che nei suoi ultimi film (Nynphomaniac e La casa di Jack: la storia di una ninfomane e la storia di un serial killer) inscena riflessioni teoriche sulle modalità di raccontare, e viene dunque equivocato. Anche Bret Easton Ellis è un provocatore. Non c’è niente di strano: più che limitarsi alla confezione (la provocazione, appunto) diventa quindi particolarmente importante la pratica dell’analisi minuziosa, dello sforzo per entrare nello specifico, della lettura riga a riga per confrontarsi con “cosa ci sta dicendo”.
Bianco è ipertrofico e denso di piste. Il nuovo libro di Bret Easton Ellis (Einaudi, pag. 280, euro 19) spiazza fin dal genere, perché rifiuta ogni etichetta: tra autobiografia e saggio, è una mescola di esperienze personali ellisiane e divagazioni sul mondo intorno. Il nostro. A partire dal titolo: ufficialmente ispirato a The White Album di Joan Didion (la raccolta di saggi preferita di Ellis), rimarca naturalmente lo statuto di uomo bianco di 55 anni in America oggi, ma Bianco è anche un colore. Quello della pagina bianca che lo scrittore confessa candidamente, dopo l’ultimo romanzo Imperial Bedrooms del 2010 (e in vista del prossimo che stavolta “potrebbe” scrivere); ma anche il colore mancante al nostro tempo, intriso di tonalità accese (il blu di Facebook, il rosso del sangue) oppure di nero, che del bianco è il contrario. Ellis vuole raffreddare la situazione, “imbiancarla”, uscire dalla semplificazione e parlare a mente fredda. Secondo lui.
Lo stato della narrativa ellissiana lo ha certificato tre anni fa la serie The Deleted (2016), da lui scritta e diretta: la storia di un gruppo di ragazzi che bevono, si drogano, fanno sesso recitando sempre nudi, talmente fuori tempo e luogo che diventava una riflessione formale sulla morte del narratore, sull’impossibilità di rifare una storia che è sempre la stessa storia. Una logica conseguenza della sceneggiatura di The Canyons scritta per Paul Schrader nel 2013, messinscena terminale sulla fine del cinema. I gusci vuoti delle ultime figure ellisiane segnalano con chiarezza il target a cui sono rivolti: occhi appassionati del meccanismo, innamorati della fine. Non può allora stupire che anche Bianco si muova sul piano formale, ovvero parta dalla forma per arrivare alla sostanza dei problemi e sviscerarli senza pietà, con sguardo fieramente soggettivo. «Non ho mai ceduto alla tentazione di dare al mio pubblico ciò che potevo immaginare desiderasse: il pubblico ero io e scrivevo per soddisfare me, e per alleviare il mio dolore».
Il libro si apre allora con una lucida ricognizione sui social network, che nell’illusione di aumentare la libertà di espressione al contrario la comprimono e riducono al silenzio: «Tutto ciò sarebbe stato impensabile dieci anni prima – l’idea che un’opinione potesse diventare qualcosa di sbagliato – ma in una società inferocita e polarizzata c’era chi veniva bloccato a causa delle proprie opinioni, e perdeva follower perché veniva percepito in modi che potevano essere inesatti (...). Come se nessuno sapesse più distinguere un essere umano da una serie di parole digitate su un touchscreen». In cambio l’era social ci ha consegnato una perenne autoscrittura di sé, la costruzione continua del proprio brand, la rappresentazione artigianale dell’ego: siamo tutti diventati attori, dice Ellis, stiamo sempre recitando. La rincorsa all’immagine migliore da postare conduce sotterraneamente al discorso sulla fruizione della cultura, con la tecnologia che rende disponibile tutto e subito, e di fatto lo sminuisce: «Il problema di stoppare un film comprato da Apple dopo dieci minuti, o di non ascoltare per intero una canzone su Spotify non si poneva nemmeno – perché farlo, dopo aver preso l’auto per raggiungere il cinema Sherman su Ventura Boulevard, la libreria Crown a Westwood, il negozio della Tower Records su Sunset Boulevard, l’edicola di Laurel Canyon?». Adesso invece «l’assenza di investimento appiattisce ogni cosa». Sapete chi la pensa allo stesso modo? I vampiri analogici in Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch, mostri che ascoltano vinili per la lentezza della cultura, per la bellezza del gesto.
È pieno di cinema, Bianco. Ellis per tirare i suoi fili spesso ricorre a film, li recensisce, vi riflette sopra, li prende a esempio per visioni del mondo: come nell’ampio spazio dedicato al racconto dell’omosessualità oggi, postilla della lunga polemica dello scrittore, gay dichiarato, contro le associazioni Lgbt per i diritti civili. L’autore stronca Moonlight di Barry Jenkins: qui il gay viene visto come Elfo Magico (geniale definizione ellisiana), una vittima al quadrato senza problematicità e asessuata, che è anche nero, insomma un personaggio in favore del pubblico. Al contrario di Weekend di Andrew Haigh il quale, a suo avviso, mostra i gay come mai prima: due ragazzi normali che si incontrano, fanno sesso e si innamorano nell’arco di un fine settimana. Due come tutti. A Ellis si potrebbe rispondere che Moonlight non cerca la verosimiglianza, non si riferisce alla realtà ma piuttosto alla letteratura, evocando perfino l’imprescindibile romanzo queer La statua di sale di Gore Vidal.
Ma non è importante rispondere ad Ellis, e qui c’è il nocciolo della questione: lo scrittore nei vari capitoli critica il movimento femminista, la superiorità morale della sinistra su Trump, i millennial che definisce Generazione Inetti, l’horror come «metascherzo postmoderno» ormai troppo didascalico rispetto agli anni Settanta («Da dove arrivavano i poteri di Carrie White? Non c’erano risposte, proprio come nella realtà»). Il punto è che non occorre essere d’accordo con Bret Easton Ellis, parzialmente o su tutto, perché a rilevare davvero è il suo metodo: Bianco non fa proselitismo, non vuole convincere ma contiene una lezione di libero pensiero. Dice quello che pensa Bret, alla sua maniera ed esagerando, quando segnala il rischio della deriva orwelliana: l’unico possibile “messaggio” è uscire dal recinto dell’opinione precostituita per costruirsi la propria. Ricordarsi che l’ideologia non riassume la complessità dell’uomo. Tornare a giudicare l’arte con la lente dell’estetica e non della politica. Citando Springsteen: guardate l’opera d’arte, non l’artista.
E se guardiamo Bianco vediamo (anche) grande letteratura. Ellis descrive il burnout dell’attore Charlie Sheen, perso tra alcool, droga e prostitute, fino al licenziamento dalla popolare sitcom Due uomini e mezzo, per poi ritrovarsi nelle interviste televisive sostenute con disturbante onestà: «Sheen stava facendo saltare in aria il mito secondo cui gli uomini superavano la ricerca adolescenziale del piacere, perché i fugaci fremiti di quel sogno non si esaurivano mai». A proposito del sogno e della sua distruzione, nelle pagine aleggia sempre l’ombra di American Psycho, il capolavoro del 1991 portato sullo schermo nel 2000 da Mary Harron, incapace di restituirne la complessa grandezza (ma gli adolescenti negli Usa ad Halloween si vestono ancora da Christian Bale con l’impermeabile trasparente insanguinato). Ebbene, lo yuppie psicopatico Patrick Bateman appartiene agli anni Ottanta ma si addice al nostro tempo: Ellis lo immagina mentre rimorchia su Tinder e posta gli addominali su Instagram. Nel narcisismo del presente Bateman è il selfie definitivo.