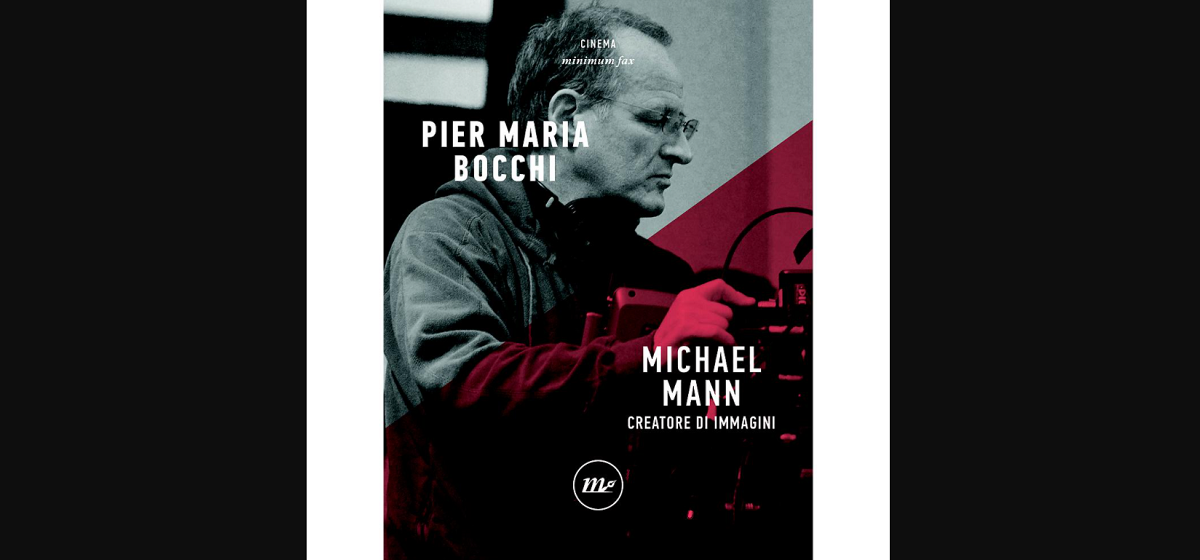Blackhat / Michael Mann - Altrove
Smarriti, fuggiamo insieme a Nick Hathaway e Chen Lien, sognando un’altra vi(t)a, un altro mondo, lontano da tutto e da tutti, fino all’angolo più estremo e remoto della terra

In Blackhat c’è un momento apparentemente secondario o comunque ininfluente ai fini dello svolgimento della storia, eppure capace di condensare in una manciata di secondi (e di pixel) un mondo di sentimenti, visioni, immagini. Stiamo parlando del breve campo/controcampo che segue la morte di Carol Barrett, raggiunta improvvisamente da una pallottola nello scontro a fuoco con Elias Kassar e i suoi scagnozzi.
Subito dopo essere stata colpita, la donna si accascia a terra. Ha gli occhi spalancati e inumiditi dalle lacrime (una di queste le solca il viso), in una fissità eyes wide shut che sintetizza al contempo il dolore della ferita, lo stupore della morte (che coglie sempre di sorpresa e trova sempre impreparati) e la persistenza di un’immagine, di una visione impressa nella retina - ovvero quella dell’undici settembre, in cui perse il marito - che la accompagna fino agli ultimi istanti di vita, sovrapponendosi al grattacielo che vediamo attraverso i suoi occhi. Un grattacielo fra i tanti che costellano lo skyline di Hong Kong, senza particolari aspetti degni di nota. Un altro luogo probabilmente non avrebbe fatto la differenza, almeno non per la donna, perché in fondo, come confessato nel corso del film, quel trauma è sempre stato con lei. Potremmo persino pensare che la morte in quel punto preciso sia una pura coincidenza, un semplice scherzo del destino, l’ultima beffa di una vita condotta costantemente sulle soglie di un dolore indicibile. Eppure quell’immagine chiama direttamente in causa lo spettatore, perché lo spinge a superare le soglie del visibile, andando oltre il personaggio e l’istanza narrante. Di colpo quell’immagine, o meglio il suo link diretto con quanto viene evocato, pare portare a compimento la riflessione teorica che sottende il film: filmare e attraversare l’enorme massa di invisibilità che ci circonda fino a tornare al corpo. Mann evita accuratamente qualsiasi enfatizzazione o sottolineatura: quel frame racconta ogni cosa senza bisogno di raccordi o sovrimpressioni. E’ tutto condensato nello sguardo del personaggio, nel luccichio dei suoi occhi e nello scarto che separa ciò che vede da quello che vediamo attraverso la sua prospettiva. In questo preciso momento il fuori campo si spoglia di ogni mistero, pur conservando “intatta” la sua consistenza fantasmatica.
In relazione a questo viene in mente quel che dice Derrida in una celebre intervista con Enrico Ghezzi sull’undici settembre [1], ovvero che l’aspetto traumatico dell’evento è stato dettato non tanto e non solo dalla morte di migliaia di persone, quanto dall’invisibilità di quelle immagini: “[ciò] che non siamo riusciti a vedere in quell’istante perché era escluso dal campo […] tutto quello che era fuori da New York, ma anche ciò che era nascosto nelle torri. I corpi che stavano sparendo, nascosti negli aerei...quindi invisibili perché esclusi dal campo”. Un’invisibilità tanto più paradossale per un evento di tali proporzioni, avvenuto praticamente in diretta e che ha goduto di una copertura mediatica senza precedenti (i punti macchina dislocati ovunque, i replay, gli zoom, ecc..). Eppure, nonostante questo, qualcosa è sfuggito al controllo dell’immagine. In primo luogo le dinamiche dell’attentato, e poi le vaste aree di invisibilità presenti all’interno delle inquadrature.
Non sappiamo se effettivamente Mann abbia pensato all’undici settembre in questi termini, probabilmente se n’è servito come antefatto per dare profondità al personaggio, eppure non possiamo fare a meno di interrogarci su tale scelta nell’economia del film, come se in qualche modo il regista abbia ravvisato in quell’attentato l’atto inaugurale dell’epoca che viviamo. Un’epoca contraddistinta, appunto, da un’invisibilità diffusa. Che è poi, oggi, quella della rete e di internet, in cui si creano legami sotterranei, collegamenti, relazioni ed eventi, senza passare per l’azione fisica (ad esclusione, naturalmente del movimento delle mani), per la concretezza della materia, se non in quanto “danno collaterale” del gesto virtuale. Anche l’attentato terroristico alla centrale nucleare cinese è frutto di un’azione invisibile: quella di un hacker che con l’ausilio di un virus fa saltare l’impianto di raffreddamento, provocando un’esplosione. Ma come inquadrare questa invisibilità di cui siamo ormai ammantati? Come dare forma a qualcosa che è impossibile vedere e toccare, se non mediati da uno schermo e da una tastiera? Mann risponde a questi interrogativi proponendo una serie di ipotesi che si intersecano tra loro: 1. filmare direttamente il flusso di informazioni che circolano nella rete, come nel vertiginoso incipit. 2. raccontare quel che è possibile fare con un computer, mettendo in scena le azioni di un gruppo terroristico e di chi gli dà la caccia. 3. trasferire nel mondo virtuale il terreno principale dell’opera. Queste risposte, sempre provvisorie, ci dicono della grandezza di Blackhat, oggetto disperso in ogni luogo e in ogni forma - frantumato, deterritorializzato - e al contempo della sua fragilità strutturale, della sua consistenza “liquida”. Mai nessuno aveva tentato in modo tanto sistematico e lucido di raccontare il nostro tempo presente, cercando di coniugare la narrativa classica (o quel che ne è rimasto) alla pura avanguardia digitale.
Guardando ai deludenti risultati al botteghino ne comprendiamo le ragioni. Semplicemente perché, ed è doloroso ammetterlo, il mondo di oggi non ha più niente di cinematografico. E’ già oltre il cinema, inteso come luogo di fruizione e come linguaggio. Un uomo solo davanti ad un computer è solo un uomo solo. Le possibili tracce narrative delle nostre azioni quotidiane andrebbero semmai cercate all’interno dei sistemi operativi, nei motori di ricerca e nelle applicazioni, nelle conversazioni, nei dati che scambiamo e condividiamo. Ovvero definitivamente fuori da ogni referente immaginario novecentesco. In questo senso il film sembra dircelo in più di una occasione: ci si sente persi, smarriti, a volte confusi, spesso soli davanti ad un groviglio di azioni da cui non riusciamo a districarci, a capire il meccanismo. Ci si sente estromessi, come se la narrazione si svolgesse costantemente altrove, in modi e forme che lo spettatore non può comprendere, se non in via intuitiva. Di qui quello slittamento progressivo dalla macchina al corpo che in molti hanno giustamente rilevato. Puro atto resistenziale capace di aprire una breccia nelle maglie dell’inquadratura, di squarciare quella coltre di invisibilità che ci circonda e ci controlla. In nostro aiuto accorrono, allora, schegge di cinema novecentesco: l’eroe palestrato, il plot di genere, le sparatorie, gli inseguimenti, come a voler rimanere aggrappati agli ultimi bagliori di un’umanità perduta. Un’umanità violenta, contraddittoria, a volte cinica o feroce, ma ancora maledettamente fisica, in cui si duella con i coltelli, ci si protegge con sciarpe e riviste, in cui ogni pallottola è una sentenza e ogni bacio una promessa per l’avvenire. Ma non c’è più tempo per la continuità, bisogna sopravvivere. E allora saltano i raccordi, viene meno il principio di causa-effetto, a volte persino la “credibilità” dei dialoghi. Smarriti, fuggiamo insieme a Nick Hathaway e Chen Lien, mentre sogniamo un’altra vi(t)a, un altro mondo, lontano da tutto e da tutti, fino all’angolo più estremo e remoto della terra, là dove nessuno potrà mai trovarci.
Sogniamo un cinema, questo cinema, che ha il coraggio di superare se stesso, prendendosi tutti i rischi possibili, anche a costo di “fallire”, che si interroga sulle forme del reale, che ci sbatte in faccia l’a-filmicità dei nostri tempi fino all’astrazione, fino al dissolversi (definitivo?) dei corpi lungo l’ultima via di fuga possibile: fuori campo. Altrove.
[1] Lo spettacolo disintegrato. Parola (su una) data di Enrico Ghezzi (2003)