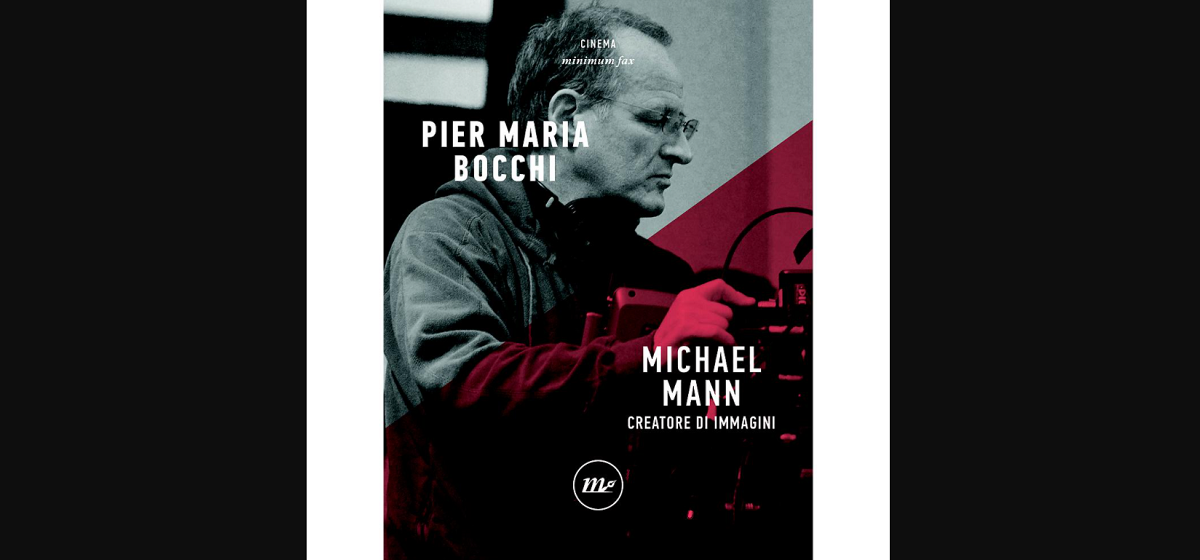Blackhat / Michael Mann - Lo spettatore ideale
Sperimentale e classico, riflettere sullo stile di Michael Mann e la sua (dolorosa) crisi nel dialogare con il pubblico contemporaneo

Blackhat di Michael Mann è uscito nelle sale statunitensi il 18 Gennaio 2015 incassando complessivamente 7 milioni di dollari. Ai quali bisogna sommare altri 9 milioni incassati nel resto del mondo. Per un film costato circa 70 milioni è un disastro che ha pochi eguali nella recente storia del cinema americano. Un insuccesso che a qualche cinefilo nostalgico può aver fatto tornare alla mente l’impressionante sequenza di flop (Un sogno lungo un giorno di Coppola, Il salario della paura di Friedkin, 1941 di Spielberg e I cancelli del cielo di Cimino) con la quale si è storicamente indicata la fine della New Hollywood e delle libertà creative e produttive che gli Studios avevano lasciato ai registi durante gli anni Settanta.
Ma il flop di Blackhat difficilmente verrà ricordato come un momento di passaggio nella storia del cinema: il rischio è che segni unicamente una brusca battuta di arresto nella carriera di uno dei registi allo stesso tempo più idolatrati e incompresi degli ultimi trent’anni. Il caso di Blackhat è esemplare per come ha visto un fronte di cinefili difendere il film (con iperboli come “Michael Mann è il più grande regista vivente”) contrapponendosi al grande pubblico che ha ignorato, quando non detestato, l’opera.
L’operazione che compie Mann è, come sempre nel suo cinema, estremamente semplice e complessa insieme. Girando per la prima volta interamente in digitale, il regista di Chicago porta a compimento con Blackhat un’idea di forma filmica indagata per la prima volta in Collateral (2004) e sulla quale ha continuato a lavorare lungo tutto lo scorso decennio. In estrema sintesi il lavoro di Mann consiste nel tentativo di sondare le possibilità restitutive del cinema digitale, portare il cinema laddove la pellicola si era arresa (le notti a bassissima illuminazione sono l’esempio più caratteristico) e più in generale costruire un’architettura visiva che sembra voler ricalcare il più possibile il bombardamento d’immagini cui siamo sottoposti quotidianamente.
La forma filmica di Michael Mann ha bisogno di un montaggio serratissimo nella misura in cui le sue immagini sembrano voler mappare un mondo, il nostro mondo, catturato da punti di vista, supporti e definizioni ormai potenzialmente infiniti.
Tra l’altro la grana di queste immagini, evidente nella visibilità delle scene buie ottenuta grazie agli ISO tenuti molto alti, è stata una delle prime sfide lanciate a tanta cinefilia nostalgica della pellicola. Se Tarantino si ostina a girare in pellicola nella venerazione delle bruciature, dei graffi e dei difetti (che in Death Proof ha addirittura ricreato in postproduzione) Mann scommette sulla perfetta adesione tra il culto per la grana della pellicola e il culto che un giorno riguarderà la grana del digitale.
Sono questi aspetti a fare della sua filmografia una delle “visioni” teoricamente più stimolanti di tutto il cinema contemporaneo, principale motivo dell’adorazione di cui Mann gode presso gli addetti ai lavori e la critica più attenta.
E il pubblico? Non parliamo qui di un regista da festival amato fatalmente da pochi, ma di un cineasta che pratica un cinema molto costoso all’interno dell’industria statunitense. Un cinema che ha bisogno del pubblico per poter esistere.
Ci vorremmo sbagliare ma l’impressione è che lo spettatore di oggi, che pure vive in un mondo digitale, interattivo, dominato dalle immagini, non abbia (più?) gli strumenti per leggere un film a partire dalla sua forma e, appunto, dalle sue immagini.
Uno dei suoi film più amati dal pubblico è Collateral, un film fin troppo ben scritto e strutturato, logico e consequenziale, che Michael Mann ha utilizzato come piattaforma per la sua prima affascinante immersione nel cinema digitale. Un racconto come quello di Collateral è un qualcosa che non appartiene al regista, al suo modo frammentario, caotico e intelligentemente contemporaneo di raccontare storie. Ma nonostante questo, o forse proprio grazie a questo, è stato uno dei suoi maggiori successi al box office.
Blackhat invece non fa che risanare la frattura tra forma e racconto di Collateral: qui, in maniera ancora più radicale che in Miami Vice, Mann costruisce una narrazione che è il preciso corrispettivo della sua forma filmica. Le ellissi, le omissioni, le parentesi dal racconto principale sono l’equivalente narrativo della sua forma, del suo sguardo attento a ogni particolare, capace di perdersi nei dettagli più insignificanti e di sognare astrazioni solo apparentemente in contraddizione con la sua attenzione per i volti degli attori e per i loro corpi.
Sembra però che un tipo di narrazione simile, che si sforza di restituire la rapidità e l’eterogeneità del reale, non riesca ad incontrare i gusti di un pubblico che pure vive in un mondo reso rapido ed eterogeneo dalla rivoluzione informatica.
Christopher Nolan, regista spesso paragonato a Mann ma con il quale ci sembra condividere solo la totale assenza di ironia, realizza un cinema dove la narrazione è sovrana, dichiarata, esposta in ogni sua minima sfumatura: come se il pubblico di oggi, sfiancato dalla vita informatizzata, avesse bisogno di storie solide, chiare, facilmente leggibili. Forse è anche questo uno dei motivi dell’esplosione negli ultimi dieci anni del fenomeno delle serie tv, caratterizzate dal ritorno alla solidità della scrittura: l’ambiguità e la polisemia possono ovviamente esistere ma sempre a partire da un racconto forte e strutturato, non da narrazioni frammentate, intermittenti, deliberatamente imperfette.
Il notevole sforzo che Blackhat richiede allo spettatore è invece uno sforzo necessario a risanare i buchi del racconto, a ricostruire le identità dei personaggi e le loro relazioni, tutti aspetti che, a uno sguardo superficiale, possono portare a considerare il film “scritto male.”
La grande difficoltà di Blackhat si trova qui, nella capacità che il suo pubblico deve avere per ricondurre le schegge e i frammenti del suo cinema a una compattezza che si trova inevitabile fuori campo. Un fuori campo che ci sembra possa facilmente coincidere con la storia del cinema classico. Solo chi ha amato nel profondo il finale di Sfida infernale, la morte in riva al fiume di Slim Pickens in Pat Garrett e Billy The Kid, il cinema di Howard Hawks o John Huston, può ricostruire mentalmente il puzzle di Michael Mann, riconoscere, dietro l’essenzialità narrativa dei suoi protagonisti, gli archetipi e i conflitti che hanno reso grande il cinema classico. Quando esplode improvvisa la passione tra il protagonista Hathaway (chiamato come il regista de Il Grinta) e Lien Chen, lo spettatore cinefilo non può non riconoscere l’adesione di Mann all’eterno, irresistibile cliché dell’amore impossibile tra due soggetti destinati a soffrire in nome della loro unione e rimane, lo spettatore, a bocca aperta davanti al modo in cui il regista non costruisce intorno a questa sequenza un contesto credibile che “prepari” in qualche modo la sequenza stessa, ma lo esibisce magnificamente come pura funzione residuale del grande cinema hollywoodiano. E’ solo dopo questo passaggio che può partire il grande gioco interpretativo della critica più attenta, capace di guardare al film di Mann, e alle sue ambiguità di senso, con esiti spesso davvero stimolanti.
Viceversa lo spettatore non cinefilo, che magari insegue ogni novità in sala ma che ha perduto una vera memoria storica cinematografica, non riesce a leggere nulla oltre il luogo comune esibito. Che resta appunto un luogo comune, un’ovvietà, una banalità di scrittura.
Michael Mann esige dal suo spettatore ideale un grande amore per la storia del cinema, un bagaglio di conoscenze necessarie per completare le parti mancanti del suo racconto, per interpretarne le zone opache e condividere con il regista una visione del cinema lucidamente contemporanea che non può però fare a meno del passato. La cinefilia che un regista come Tarantino richiede al suo pubblico è una passione di superficie, un gioco lanciato allo spettatore – vediamo quanti riferimenti riconosci – ma che non ha nulla a che vedere con la fruizione e la godibilità dei suoi film. La cinefilia dello spettatore di Blackhat è molto più profonda, impegnativa, indispensabile.
Davanti al rifiuto del film da parte del pubblico viene da chiedersi: accanto alla proposta di Michael Mann può esistere un’altra idea di cinema industriale capace di calarsi nel contemporaneo - secondo un’adesione sia stilistica sia narrativa - senza rinunciare a un’epidermica empatia di primo livello con lo spettatore, ma senza lasciare che questa empatia diventi sterile retromania? Qualcosa che non sia né il cinema di Harmony Korine né quello di Paul Thomas Anderson?
Stiamo cercando una risposta.