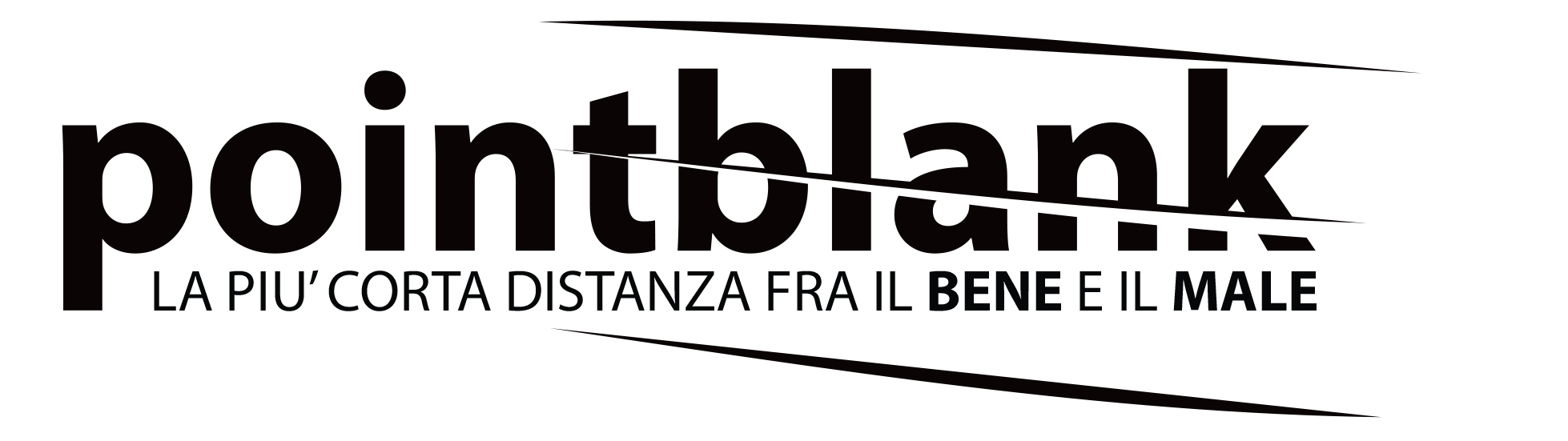Dossier Laura Poitras \ 3 - My Country My Country
Un'invocazione alla libertà di un'intera popolazione tra le immagini di una forzata democrazia d'esportazione a stelle e strisce

My Country, My Country! Recitato e cantato nei versi di una canzone tra il dolore e la speranza del popolo iracheno. Una preghiera mossa da una musica struggente che vibra nell’aria, che dai minareti si riversa fin dentro le moschee, che si confonde con il frastuono delle bombe, che nasce dalle lacrime di chi ha perduto qualcuno, come un’esclamazione, o meglio, un’invocazione sotto forma di preghiera al proprio Paese in procinto di votare per le prime elezioni democratiche del nuovo corso imposto, successive alla tirannia di Saddam.
E’ questo struggente canto che accompagna le immagini finali del documentario della Poitras, primo tassello di una trilogia post 11 Settembre (composta da The Oath e dal recente Citizenfour). My Country, My Country, si disperde nell’aria come un’avvolgente manto evocativo mentre da un elicottero vediamo file di persone, di etnie differenti e spesso in conflitto tra di loro, che si riversano dentro i seggi per compiere il primo passo verso una nuova democrazia. Mentre a Falluja le persone vivono ancora sotto i bombardamenti americani, gli stessi, si adoperano per esportare il loro modello statale democratico. La Poitras con il suo occhio invisibile, che contraddistingue il suo stile asciutto, segue e riporta, documenta per mostrare all’Occidente cosa realmente accade in un Paese diviso e distrutto, soggetto prima ad una dittatura e poi ad un’occupazione straniera.
Il racconto per immagini inizia 6 mesi prima del giorno delle elezioni, per poi raccontare, in diversi passaggi temporali - tra le emozioni e le idee - la disperazione di un popolo alla diaspora civile ed i procedimenti organizzativi adoperati dalla Commissione elettorale indipendente, concludendosi poi nel giorno stesso del voto. La Poitras segue le vicende di un medico appartenente alla comunità sunnita, Dr. Riyadh al-Adhadh, diviso tra il lavoro quotidiano al suo studio di Bagdad – mostrandone l’intimità famigliare e lavorativa nello stretto rapporto con le persone che visita, spesso in disperate condizioni economiche e fisiche - e le ispezioni alla prigione americana di Abu Ghraib (alcuni mesi prima che le sconvolgenti foto venissero diffuse in tutto il mondo). Riyadh al-Adhadh, padre di sei figli nonchè rappresentate del partito sunnita, compagine politica che boicotterà solo all’ultimo le elezioni, è il collante cinematografico di una panoramica generale ed umana dell’intera popolazione irachena. Il personaggio da seguire e raccontare, il fil rouge attraverso il quale riuscire ad avere un progressivo avvicinamento descrittivo della situazione politica e sociale, fino al giorno del voto.
![]()
La regista si cimenta, prima ancora di Citizenfour, nel racconto documentale in presa diretta. La simultaneità delle riprese con gli eventi trattati instaura con lo spettatore un rapporto diretto di sincronismo, calandolo al centro della storia, stabilendo con esso uno sguardo/testimone in un rapporto paritario e dinamico, tanto drammaturgico quanto reale, traducendolo nelle spoglie di un osservatore diretto del destino politico di un’intera popolazione. Se in The Oath, l’impianto narrativo era molto più fedele alla ricostruzione dell’evento, attraverso l’utilizzo di interviste frontali e nelle immagini di repertorio selezionate tra i trafili di giornale, documenti che riuscissero a raccontare le storture di un’America all’imprecabile ricerca di colpevoli, qui, il racconto si costruisce per eventi simultanei, riconsegnati a posteriori attraverso uno sguardo oggettivo e metastorico, ma pur sempre intriganti, sincroni (al cospetto della Storia) e diacronici (al cospetto della sviluppo drammaturgico).
La Storia di una democrazia nascente dalle ceneri di una tirannia, di un popolo diviso al suo interno nelle sue varianti sunnite e sciite, in conflitti intestini tra appartenenza ed odio, un popolo disgiunto politicamente ma forte – fino all’integralismo - nelle sue fedi religiose. In questo contesto la Poitras ci presenta un Paese distrutto e spogliato delle sue ambivalenti anime d’appartenenza etnica dallo Stato straniero. Prima ancora che sulle ferite della guerra, il conflitto fa sanguinare l’anima di un popolo violentato nella sua integrità nazionale, liberato in maniera coatta dalla tirannia e costretto ad accettare una democrazia bombardata dall’alto.
Lo sguardo lucido della regista non appartiene a nessuna bandiera e non abbraccia nessuna corrente politica, né democratica né tantomeno repubblicana, ponendosi al centro, svincolata da qualsivoglia dottrina, rasente solo la realtà che racconta. Mentre l’eroismo del cecchino di Eastwood conta le vittime che entrano nel suo mirino, per poi tornare in Patria e morire da eroe (repubblicano), la Poitras ci racconta di un territorio dove si costruisce con la forza una democrazia, mentre a pochi chilometri di distanza, a Falluja, gli americani continuano nel loro sanguinoso intervento militare: per tornare in patria e raccontarsi attraverso l’epica del sopravvissuto che ha combattuto fedelmente per il proprio Paese. Una nazione con tante stelle su strisce di sangue versato.