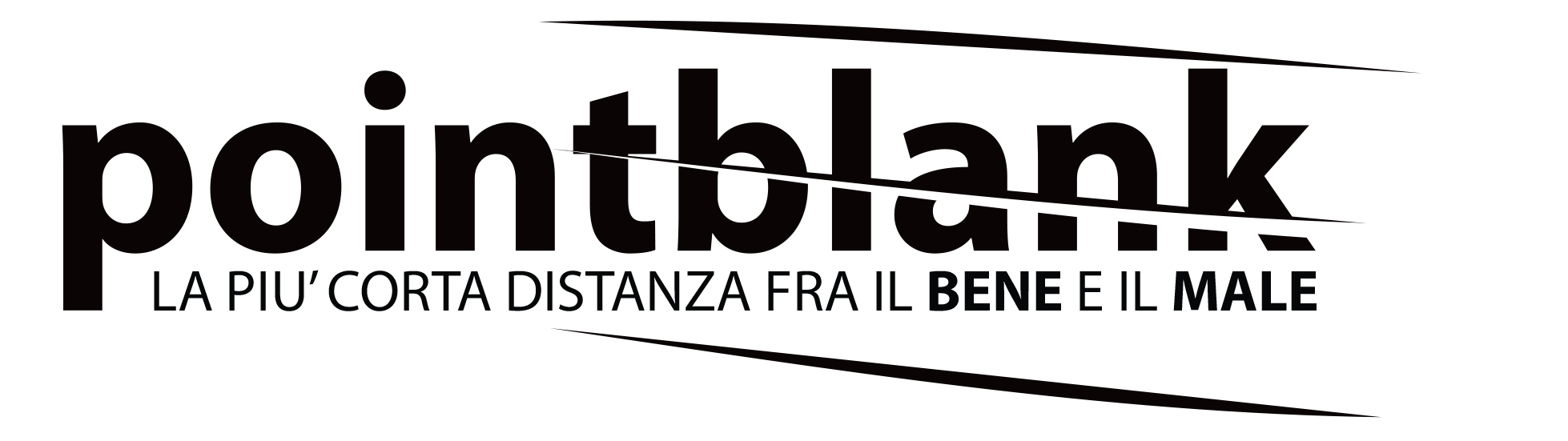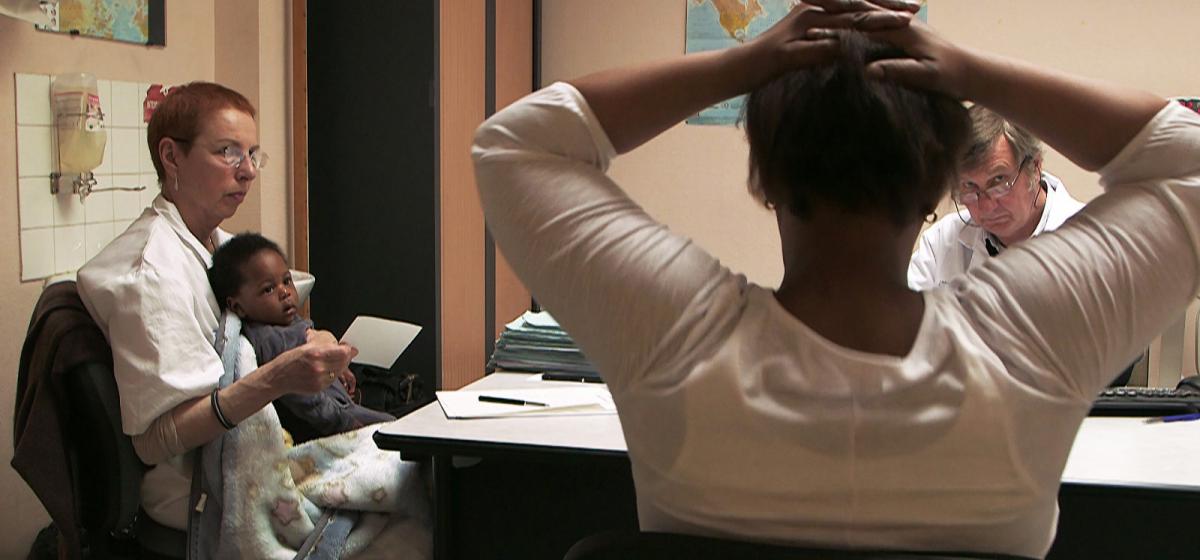Dalla fine degli anni sessanta, grazie alla singolare maestria di George A. Romero, l’horror cambia i suoi connotati. Film come La notte dei morti viventi (1968) e Zombi (1978) hanno segnato uno spartiacque storico del genere, divenendo da puro mezzo fantastico arma culturale per affrontare tematiche sociali e politiche. Quindi Romero fu forse il primo, assieme a John Carpenter e all’asiatico Shinya Tsukamoto, a rendersi conto delle potenzialità sociali del genere. L’immagine degli zombi che affollano un disabitato centro commerciale è tuttora attuale come suggestione critica della società dei consumi. Recentemente lo stesso Romero è andato anche oltre, riformulando nuovamente il genere e portandolo all’estrema funzionalità di film-saggio. E’ il caso di Diary of the Dead – Le cronache dei morti viventi, 2007), che teorizza con grande lucidità le nuove funzionalità storico-sociali del video digitale, dal punto di vista mediatico da un lato e come cambiamento radicale dell’apparato cinematografico stesso dall’altro.
Dopo questa breve introduzione di carattere storico comprendiamo quindi come, negli ultimi anni, l’horror abbia raggiunto una certa maturazione tematica. Svincolato ormai dalle innumerevoli trasposizioni letterarie di romanzi dell’orrore, il genere gode di una nuova fase, che fa capo a pochi autori che ne hanno saputo formulare nuove ed intelligenti prospettive. Su tutti, oltre al già citato Romero, va sicuramente annoverato il canadese Bruce McDonald, autore di numerose serie televisive e di uno dei più interessanti film horror degli ultimi anni, Pontypool – Zitto o muori, del 2008 (in Italia distribuito solo in dvd).
Per certi versi Pontypool è anch’esso un tentativo teorico d’indagine sulle funzionalità sociali dei mass media ed in particolar modo della radio, protagonista assoluta di questa geniale pellicola. Per prima cosa ciò che colpisce di quest’opera è la dicotomia interno/esterno; l’intero film, a parte una breve sequenza introduttiva, è ambientato all’interno di una stazione radiofonica. Non è questa però la vera innovazione dell’opera di McDonald, quanto il fatto che gli eventi, o meglio il nucleo drammatico della storia, rimangano sempre nel fuori campo, ovvero all’esterno della stazione radiofonica, escludendo in questo modo non solo i protagonisti ma anche lo spettatore dalla visione spaventosa di ciò che avviene fuori dalle mura di quel palazzo, fuori nel mondo e nella cittadina di Pontypool. Come afferma lo stesso protagonista del film, l’eccentrico speaker radiofonico Grant Mazzy, citando il filosofo francese Roland Barthes, il trauma di questa storia è come una fotografia di cronaca senza didascalia, con la differenza che nel film è presente la didascalia, la parola, e non la fotografia, l’immagine. Ciò che destabilizza letteralmente nella percezione di Pontypool è proprio l’assenza, la mancanza perturbante dell’immagine a favore, invece, della parola, strumento primordiale della trasmissione dei fatti e delle notizie. Ed è per tal motivo che la radio, ancora oggi, è un mezzo privilegiato e diretto rispetto ad altri come la carta stampata.
Le cose però si complicano in modo definitivo, perché nel corso del film capiamo che è proprio la trasmissione della parola ad essere la causa sintomatica di ciò che sta avvenendo nella cittadina dell’Ontario, Pontypool, dove all’improvviso, in una gelida giornata di inverno, le persone, riunite in una sorta di manifestazione di fronte lo studio del dottor John Mendez, iniziano a ripetere frasi sconnesse, a pronunciare slogan nazisti, attraverso l’uso di lingue minacciose come l’arabo e il tedesco, fino a raggiungere uno stato di cannibalismo sfrenato. Tuttavia, com’è stato specificato in precedenza, tutto questo non è visibile; noi ne siamo informati grazie agli inviati (sempre invisibili) della radio CLSY, che attraverso il telefono raccontano in diretta ciò che al di fuori sta succedendo. Per circa metà del film si vive quindi in una sorta di limbo, identificati con l’incredulità dei protagonisti, incapaci di verificare con esattezza la veridicità degli eventi e quindi informatori parziali, perché la loro conoscenza è filtrata dall’esperienza altrui. Ed è questo il limite definitivo dell’apparato radiofonico, sembra dirci Bruce McDonald.
Tuttavia essi non saranno esonerati dalla possibilità di vivere sulla loro pelle ciò che sta succedendo, perché ad essere infettati saranno una di loro ed lo stesso dottor Mendez, scampato all’aggressione dei cannabili e rifugiatosi all’interno della stazione radiofonica. E sarà proprio quest’ultimo a comprendere il meccanismo di diffusione del virus, che non è virale ed organico, quanto connesso alla diffusione delle parole. Ad aggravare tale condizione è quindi la radio stessa, che ha riprodotto all’infinito parole nella mente umana fino a produrne tali sintomi. L’apparato radiofonico, che in un primo momento era l’unico strumento di informazione degli avvenimenti che hanno sconvolto Pontypool, adesso si capisce esserne l’artefice. Questo ci ricorda con forza l’affermazione di Marshal McLuhan, riguardo al fatto che il “mezzo è il messaggio”, e come ci ricorda Umberto Eco tutto questo presuppone la morte dell’uomo gutenberghiano e porta alla nascita di un uomo tutto nuovo, che a quanto pare per Bruce McDonald assume i tratti di uno zombi.
La soluzione proposta dal dottor Mendez all’interno del film è definitiva: bisogna interrompere la trasmissione, eliminando così la diffusione del virus. Ma in questo frangente si insinua un dibattito teorico di non poca importanza, ovvero la domanda su cosa sia più importante fra il diritto di informazione e l’incolumità degli spettatori. Non vi sono altre soluzioni al quesito, tale diritto viene meno nel momento in cui l’informazione è lesiva. Per tal motivo lo speaker Grant Mazzy è costretto a chiudere ogni contatto con l’esterno.
Tuttavia secondo quest’ultimo il problema non sarà debellato se non ad un costo più elevato, ovvero attraverso la decostruzione linguistica della parola, riutilizzata proprio come nella poesia avanguardista per la creazione, attraverso l’associazione casuale di termini, di un processo di significazione tutto nuovo. Sarà proprio attraverso l’apparecchio radiofonico che egli sperimenterà tale guarigione. Non è la radio (o il mezzo mediatico) il vero problema quindi, quanto l’utilizzo linguistico che se ne fa. Questo è il fine teorico proposto da Pontypool in modo definitivo. E cosa, a nostro avviso, più interessante è la proposta di decostruzione del linguaggio che nel film avviene a più livelli: sia dell’immagine cinematografica, incapace a volte di essere testimone visiva dei fatti, e sia del linguaggio vocale usato (in)consapevolmente dai mass media per la costruzione di una nuova società di carattere apocalittico.
Come non chiudere quindi con una frase del citato Diary of the Dead di Romero, quando l’aiuto regista del film indipendente che si sta girando afferma “è uno stupido film del cazzo” e in tutta risposta il personaggio del professore, alter ego di Romero stesso, ribatte “si, ma con una sottile lineatura di satira sociale”.