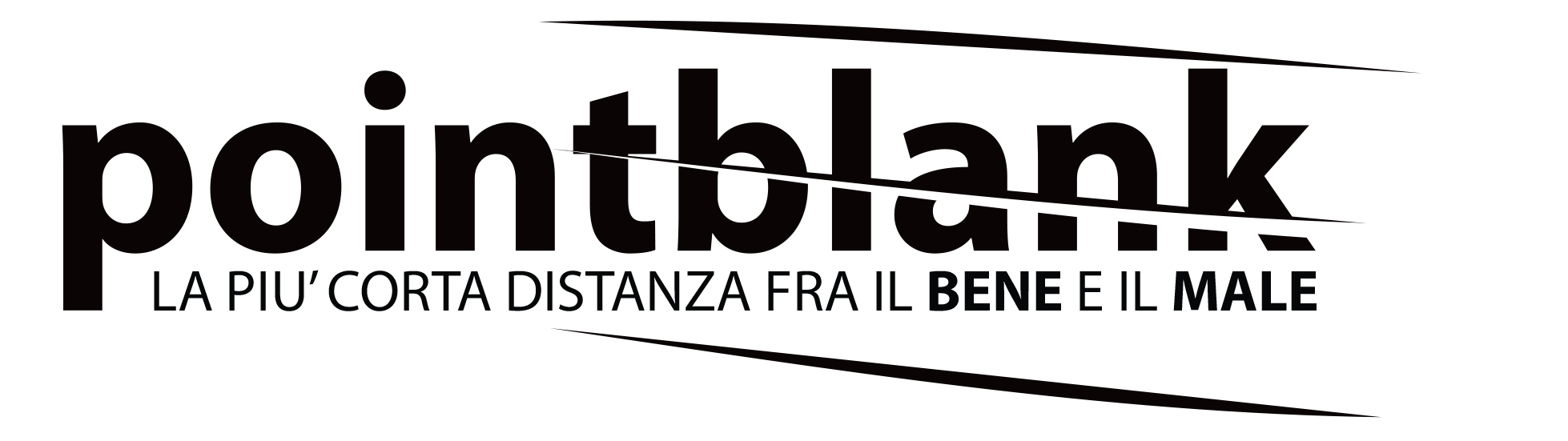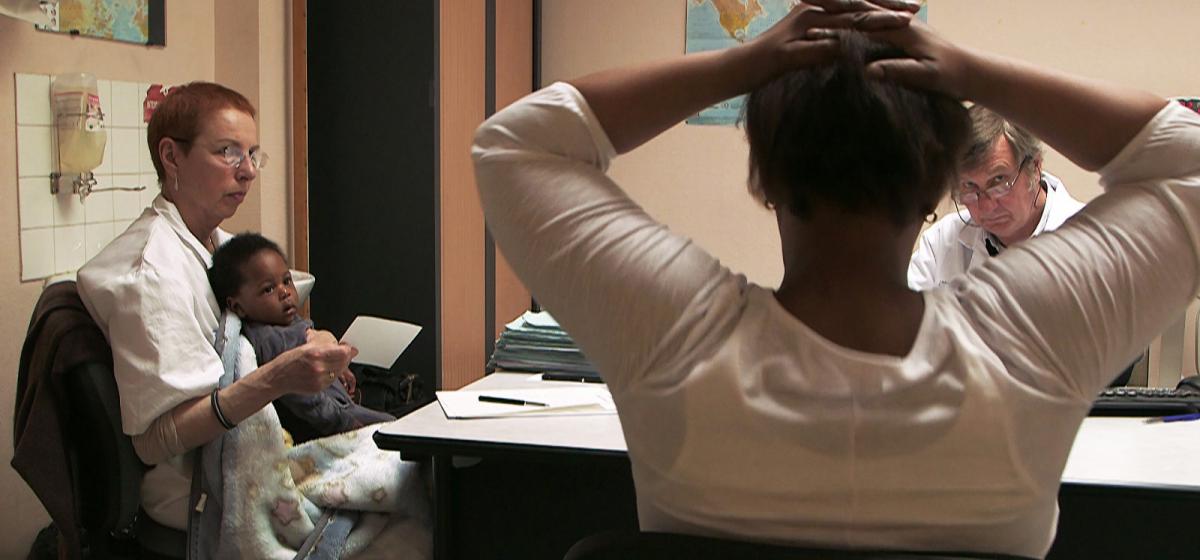Ci sono cose di cui è difficile parlare, figuriamoci scriverne, o addirittura filmare, perché incorporee senza peso né gravità, leggerissime e invisibili come il vento o l’aria, fragili come il cristallo. Appena le nomini spariscono, perdono improvvisamente quel poco di consistenza che credevi avessero, le banalizzi fino a ridurle ad una formula, ad una frase più o meno riuscita, ad un inquadratura più o meno bella, intensa, giusta. L’amore naturalmente è una di queste, forse l’unica insieme alla morte (ma qui Wenders mi darebbe torto) che non è possibile raccontare, esprimere con le parole, e soprattutto catturare con la propria macchina da presa. Possiamo descrivere le conseguenze che questo sentimento ha su di noi, le emozioni che proviamo in determinate circostanze, il cuore che batte improvvisamente quando lo riconosciamo negli occhi e nel volto dell’altro/a, la pancia che si chiude, il nervosismo che ti assale, le mani che sudano, l’entusiasmo delle prime volte. Oppure la sofferenza che provi quando ti accorgi che finisce, che non c’è più niente da fare, che quella magia, quella cosa che non sai neanche bene cos’è, non c’è più e non tornerà mai più. La cosa più difficile, forse impossibile, però non è parlare del prima o del dopo ma del durante, di quel tra che unisce due persone per un periodo delle loro vite. Come possiamo raccontare una cosa del genere? Alla carta o alla cinepresa dovremmo sostituire i corpi, e lasciare che siano loro ad esprimersi direttamente senza intermediari né metafore; ma come fare? E poi come nasce l’amore? Che forma ha? E quanto può durare? Quali sono le cause che lo fanno morire inaspettatamente? Non esiste altro caso nella storia del cinema che possa anche solo avvicinarsi a quello di Philippe Garrel e del suo personalissimo percorso filmico. Nessun altro come lui ha costruito un’intera carriera sul mistero dell’amore e sulla sua infilmabilità. Un circolo ossessivo, ora più vicino, ora più lontano intorno ad una cosa (non) data, sempre precaria, o meglio, sempre già finita, esaurita nel momento stesso in cui la si mette(va) in scena. «L’amore è tutto quello che non si può dire» dice una delle protagoniste di J’entends plus la guitare. Tutto ciò, dunque, che non si può filmare. E allora non resta che costruire dei discorsi intorno ad esso, provare, per quanto possibile, a dire quel poco che (non) si sa. A raccogliere tutte le idee, i pensieri, le riflessioni. Catturare uno sguardo, un sorriso, una carezza, un volto segnato dalle lacrime.
Sarebbe troppo facile (o comunque riduttivo) sostenere che il cinema di Garrel non fa altro che rielaborare la perdita di Nico, l’amata cantante dei Velvet Underground con la quale ha vissuto un’intensa stagione d’amore durata dieci anni. Filmare la fine di quel rapporto, e il sentimento ossessivo che innesca una nuova ricerca, che rimette in circolo le forze fino alla prossima epifania. Il fantasma di Nico, semmai, funge da sineddoche dell’amore esattamente come un ciuffo di capelli biondo, una voce roca, una melodia di John Cale fa con lei e con il suo spettro, il suo ricordo. Ci sono film dove le due cose sono coincidenti, come in J’entends plus la guitare, che affronta senza reticenze né barriere brandelli di vita vissuti insieme, fino a quel tragico giorno in cui arrivò una telefonata da Ibiza che informava della sua morte, avvenuta in circostanze assurde (la caduta da una bicicletta). Oppure altri dove viene messo in scena il rapporto con Brigitte Sy, madre di Louis, in Les baisers des Secours. O ancora storie del prima e del dopo (La Naissance de l’amour, Le Coeur Fantome), dei fremiti che accompagnano un nuovo incontro o il malinconico vagabondare che segue la rottura, fino al suicidio (Un Ete Brulant) o al suo disperato tentativo (La Jalousie). Non c’è mai il mentre, il tra di cui parlavamo prima, se non nelle forme già esaurite di un rapporto al capolinea o destinato a mutare nel giro di poco tempo. Il viaggio di Garrel nella galassia dell’amore è senza paracadute né difese, un corpo a corpo costante, quasi maniacale, oltre i corpi, le superfici epidermiche, fino alle cicatrici interiori, fino al cuore del trauma. Non esistono finzioni in grado di allontanare l’oggetto del proprio discorso, tenerlo a distanza di sicurezza. Il cinema per Garrel è una questione di famiglia, maledettamente personale, al punto da fare quasi paura nella sua disperata lucidità, nella sua sincerità. Come se fosse un bambino a filmare, un essere innocente (e incosciente) che guarda (o sogna) all’amore come ad un mistero insondabile. Possiamo rintracciarlo per un attimo fuori campo, o nell’emozione di un bacio. Ma appena pensiamo di averlo visto, di averlo compreso, fugge via. Uno stacco ci trasferisce altrove, in un altro spazio, in un’altra situazione nella quale, forse, si ripeterà il meccanismo, o peggio ci verrà sbattuto in faccia il suo opposto, la rottura, il dolore. In questo senso non esiste opera più bella e intensa di La Naissance de L’amour, dove tutto questo trova il proprio posto nella narrazione, la fine della relazione con la moglie, l’infatuazione per Ulrika, e poi l’epifania inaspettata per una ragazza conosciuta al bar, ma senza che sia davvero filmato l’amore. È questo il più grande paradosso (o forse la maggiore virtù) del cineasta Garrel: essere riconosciuto come uno dei più importanti (se non il più importante in assoluto) registi dell’amore, dei sentimenti, senza tuttavia averli mai filmati.
La sua grandezza risiede proprio in questa consapevolezza e nella conseguente ossessione che innesca la ricerca, non di dargli un volto o un nome, ma di entrare negli interstizi dell’inquadratura e del cuore, di avventurarsi là dove nessun altro ha mai gettato il proprio sguardo. Non nell’immagine ma tra le immagini, nella frattura tra un’inquadratura e quella successiva, nel grande buco nero del cinema, dove ogni tanto i suoi personaggi cercano rifugio come il grande Lou Castel che si getta all’indietro dentro ai cespugli fino ad esserne inghiottito. La narrazione non è mai lineare, non inizia e non finisce mai dove ci si aspetterebbe. Un film può iniziare da due personaggi che escono da una casa, filmati quando un’azione si è appena conclusa, oppure finire, così, improvvisamente, un attimo prima di addormentarsi, o un attimo dopo aver sceso le scale della metropolitana. Allo spettatore non resta che abbandonarsi al flusso visivo e ad accogliere, con la stessa sorpresa e lo stesso stupore di Garrel quando filma (tutto sempre e solo una volta), l’affiorare dell’emozione, l’incontro casuale con l’altro/a.