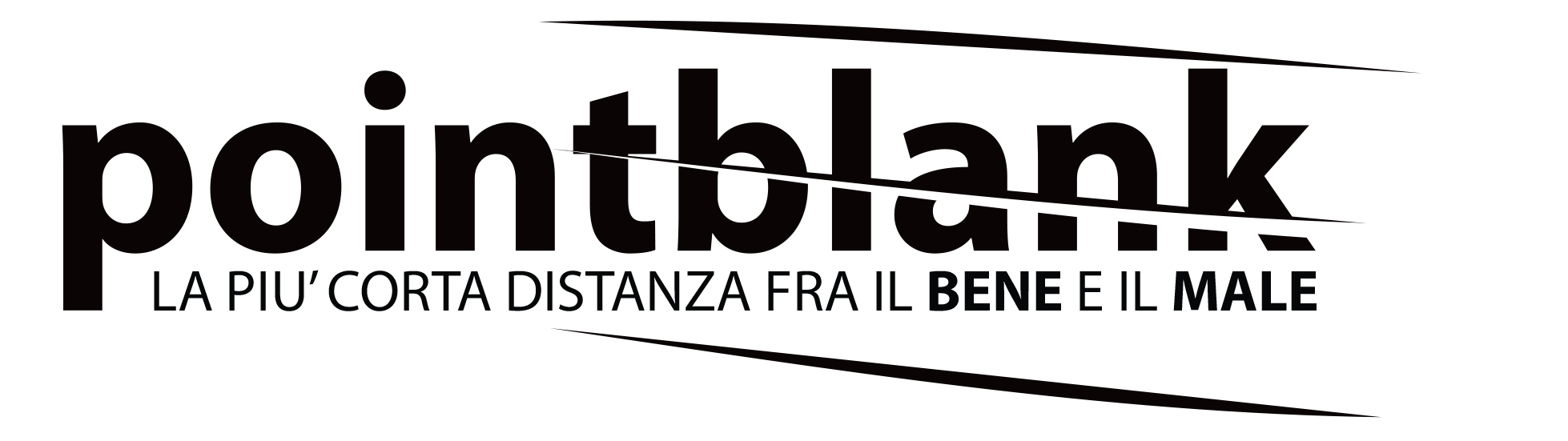The Knick/Soderbergh - Il corpo-spettacolo
The Knick si struttura a partire dalla relaziona tra medicina e spettacolo, come ricerca ossessiva di una visibilità al contempo sempre più trasparente ed opaca

"Let’s give them the show". Parole che potrebbero provenire dalla bocca di Magic Mike o del Liberace di Dietro i candelabri, eppure a pronunciarle è un uomo che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, almeno non in senso classico. John Thackery (Clive Owen), stimato chirurgo che lavora a New York all’alba del Novecento, incoraggia il suo superiore Christiansen prima di un intervento. Non uno qualsiasi ma l’ennesimo tentativo, dopo numerosi insuccessi, di scongiurare la morte nei casi di placenta previa.
Quel “them” si riferisce al gruppo di medici e luminari presenti all’operazione in veste di pubblico: come immortalato dal pittore realista americano Thomas Eakins nel suo celebre The Agnew Clinic del 1889, un tempo era infatti possibile assistervi stando comodamente seduti su palchetti di legno, in una cavea simile a quella teatrale. Non a caso la sala operatoria viene chiamata, appunto, teatro, ed è attorno a questo spazio che ruota l’intera serie: tutte le linee narrative, che si intrecciano tra i corridoi dell’ospedale e le strade di New York, rinviano costantemente ad esso, in quanto set principale della rappresentazione e dell’elaborazione dei corpi. È qui che le dinamiche tra i personaggi, i rapporti di forza, le relazioni, i giochi di potere, si cristallizzano. Come in una commedia che va in scena quotidianamente, chi vi prende parte ha un ruolo preciso, stabilito in partenza e destinato a durare nel tempo, salvo imprevisti. Al dottor Edwards, ad esempio, spetta un ruolo da mero comprimario, corrispettivo simbolico dello spazio che occupa all’interno dell’ospedale, lo scantinato, vero e proprio luogo del rimosso (la questione afroamericana e razziale). Solo nel momento in cui elabora scoperte utili, non tanto al prestigio personale o dell’ospedale ma piuttosto ad ottimizzare la performance chirurgica, rendendola ancora più precisa ed efficace, riesce ad ottenere una “parte” migliore in scena. Scoperte che hanno a che fare con il corpo, naturalmente, in particolare con l’aspirazione del sangue e con la cura dell’ernia inguinale, patologia che colpiva soprattutto i neri, forza-lavoro sfruttata dal capitalismo wasp per i lavori più duri e faticosi.
Il corpo allora si fa in The Knick materia doppiamente “spettacolare”, perché comprende tanto i pazienti, oggetto delle operazioni (che si offrono al triplice sguardo dei medici e degli spettatori del teatro e del pubblico televisivo), quanto i chirurghi, in special modo Thackery, protagonista indiscusso della serie dopo la morte del “primo attore” Christiansen, suicidatosi in seguito al fallimento della sua prova più importante. Ed è proprio a partire da questa relazione tra medicina e spettacolo che si struttura The Knick, come ricerca ossessiva di una nuova visibilità, al contempo sempre più trasparente ed opaca, in grado di penetrare la superficie scandagliandone l’interno oppure, al contrario, di nascondere, occultare il più possibile le ferite, i tagli, le abrasioni, i segni. Come fa Thackery, che si inietta l’eroina sui piedi celando la sua dipendenza, in modo da preservare la sua professionalità, e dunque l’immagine-spettacolo. “La gente adesso crede con ardore in chi riesce a fare dei miracoli: medici, inventori, architetti, sono loro le nuove divinità americane”. E allora il passo dalla scienza all’immagine è breve, come dimostra il commerciante che propone a Thackery di usare il suo nome e il suo volto per vendere un medicinale rinvigorente che non ha alcun fondamento scientifico. E non è casuale che sia lo stesso commerciante ad offrire all’ospedale uno dei primi macchinari per la radiografia. L’accesso ad una nuova visibilità del corpo, l’invenzione dei raggi X, coevo alla nascita del cinema, va di pari passo con la sua falsificazione. Ecco l’insospettabile relazione con i due film citati all’inizio: attraverso il racconto della vita di un ospedale e delle persone che lo attraversano, The Knick prosegue con implacabile determinazione lo scavo sempre più profondo tra le pieghe dei tessuti e delle immagini del corpo-spettacolo, i quali hanno caratterizzato l’ultima produzione di Steven Soderbergh, ovvero quel gruppo di opere comprese tra il bellissimo The Girlfriend Experience, che lavorava sulla dialettica tra offerta e verità dei corpi, e Dietro i candelabri, film spartiaque nel passaggio dal cinema alla televisione in cui si mostrava l’azione virale dell’immagine-spettacolo nel substrato proletario. Un contagio che prendeva forma sul lettino di un chirugo. Quello stesso lettino sul quale, appena due anni prima, il corpo di Gwyneth Paltrow veniva spogliato senza pietà della sua patina divistica, e su cui oggi giace il paese America.
L’immagine in Soderbergh si dà sempre più in tutta la sua ambigua trasparenza glaciale, liquida, che lascia intravedere quel che c’è dietro (i candelabri, il lavoro dello spogliarellista o escort) coincidendo con la patina traslucida, con il luccichio della superficie, come una sottile membrana che separa l’evento dallo sguardo dello spettatore e del fruitore, come la vetrina di un negozio o di un mausoleo in cui la merce si offre per negazione: tanto più scoperta, nuda, e tanto più opaca.
In The Knick questo scavo costante, inesorabile, punta alla levigatura dei corpi in quanto merce da reimmettere/riciclare nel ciclo produttivo. Un’indagine, quasi gore nelle sue punte più estreme, che attraversa il filo sospeso e sottilissimo che separa la vita dalla morte. Quel che mostra Soderbergh è una grande catena di montaggio in cui i corpi, vivi o morti poco importa, si presentano in tutta la loro natura commerciale ed economica. Lo sono in quanto oggetto della performance medico/teatrale naturalmente, ma anche come cavie per gli esperimenti scientifici. Fondamentale in questo senso è il lavoro del portantino Cleary, cacciatore di cadaveri, da rivendere al miglior offerente, e di aspiranti abortiste. I corpi dei pazienti alimentano inoltre il circolo della prostituzione e dunque della morte sociale. Persino i debiti vengono saldati con l’immissione nel mercato di “carne fresca”, ovvero di due ragazze cadute in disgrazia e costrette a prostituirsi per evitare la minaccia della prigione. Paradigmatico è il caso di Barrow, l’amministratore dell’ospedale, che sfrutta i guadagni derivati dai bilanci truccati, dirottandoli nelle tasche della prostituta con la quale ha una perversa "storia d’amore".
In questa relazione tra corpi e mercato il processo di decadimento è irreversibile: ad un certo punto lo spettacolo tracima e con esso la dimensione simbolica. I soggetti collassano, le maschere cadono, quasi tutti si perdono. L’esito della serie è anticipato dalla soggettiva che la inaugura: il risveglio di Thackery nella fumeria d’oppio. Controcampo leoniano dentro al cuore del mito e della Storia, che ci introduce in una sorta di incubo che troverà il suo epilogo ancora su un letto, questa volta di un ospedale. Il cerchio è chiuso.