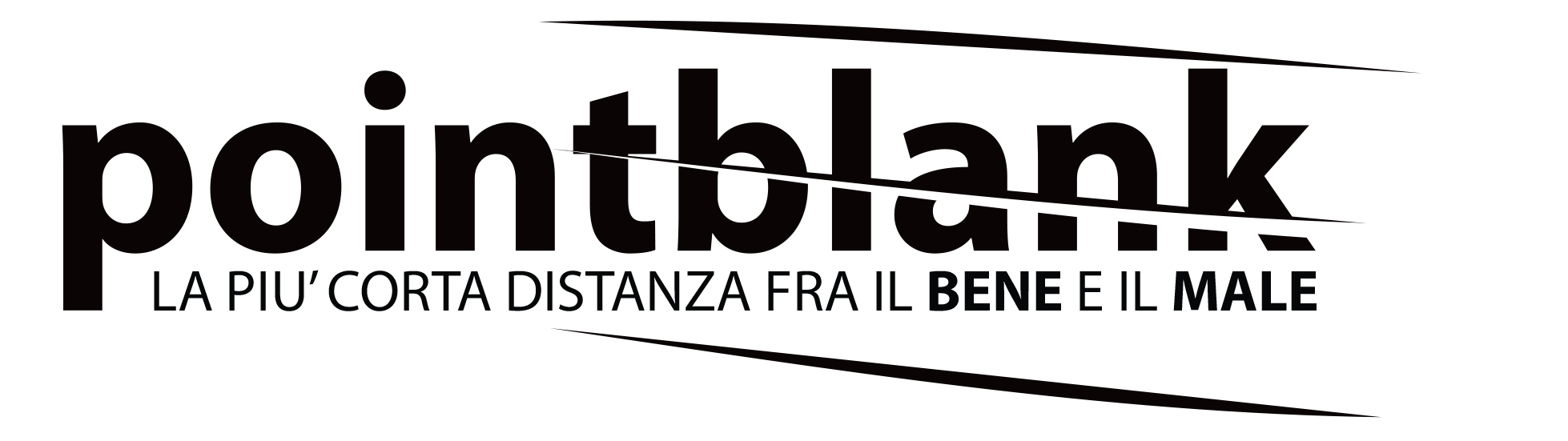Grande e piccolo schermo
My Friend Dahmer
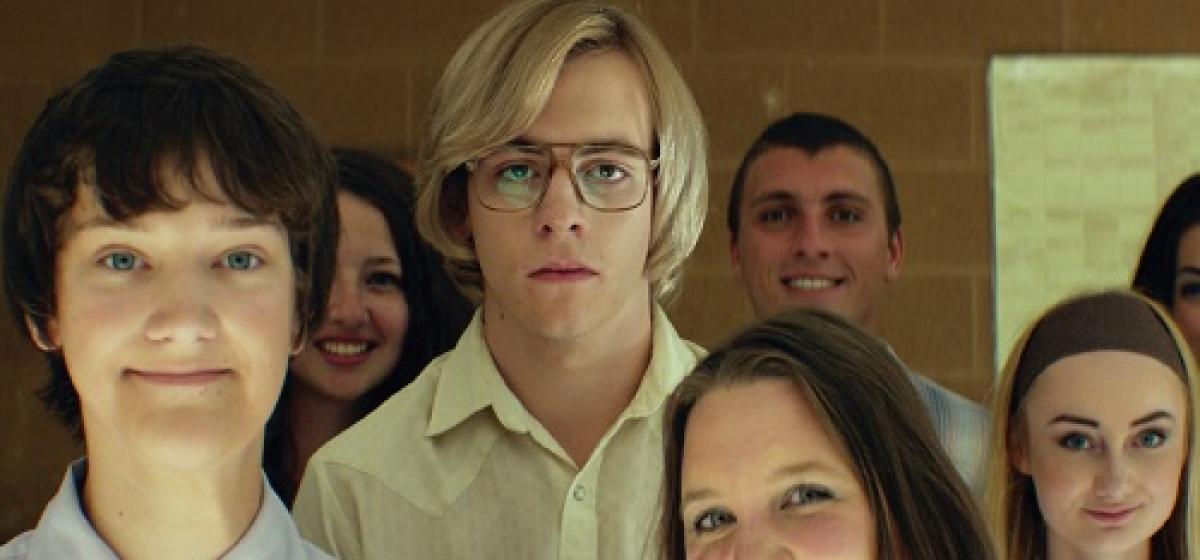
Nell’estate del 1969, all’ombra di Woodstock, germoglia il “seme dalla follia” che sfregerà per sempre il volto dell’America, avvelenando irrimediabilmente l’utopia pacifista dei “favolosi” anni sessanta ormai trascorsi. Hollywood trema sotto un’ondata improvvisa di inaudita violenza – inaugurata dalla brutale strage di Bel Air della Family di Charles Manson e centellinata dai criptici messaggi del Killer dello Zodiaco – che converte la generazione dei colorati figli dei fiori nei sanguinari “figli di Sam” del decennio successivo. Gli anni settanta verranno infatti ricordati come “l’era dei serial-killer”: una decade che ha visto emergere in rapida successione - dalle pagine della cronaca nera - un’orda di “nuovi mostri” provenienti dagli angoli più bui della provincia americana e destinati a soppiantare quelli “classici” - meno credibili ed efferati – nell’immaginario collettivo del pubblico. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di Jeffrey Dahmer, protagonista assoluto del film biografico My Friend Dahmer, interpretato dal fenomenale Ross Lynch nel ruolo del giovane assassino: una delle pellicole rivelazione del 2017, scritta e diretta dall’estroso Marc Meyers (How I Fell In Love).
Probabilmente tutti gli appassionati di crime-show e legal-thriller televisivi conoscono a memoria i dettagli della vicenda pubblica e giudiziaria di Dahmer, noto ai più come “il cannibale di Milwaukee”: il serial-killer più controverso del ventesimo secolo – omicida, necrofilo, omosessuale – che ha divorato diciassette ragazzi tra il 1978 e il 1991, rivelando al mondo l’orrore di un esistenza oscura, vissuta oltre i confini di ogni macabra fantasia. In pochi, invece, conoscono la sua vita privata, quella prima del suo primo delitto che lo vede ancora seduto tra i banchi di un liceo qualsiasi dell’Ohio nei panni di un adolescente malinconico e stravagante – come tanti - alle prese con le prime sbronze, le bravate con gli amici e le turbe esistenziali dell’epoca pre-reganiana. Tutti innocenti riti di passaggio collettivi che - nel caso di Dahmer – non sono altro che timide richieste d’aiuto prima di affondare in un inferno privato di pulsioni scabrose ed istinti inconfessabili.
Questa è la storia che sceglie di raccontare il regista Marc Myers nel suo film: un particolarissimo making of di un assassino, basato sui ricordi e sulle immagini di Jeff “Derf” Barker - amico ed ex compagno di classe di Dahmer - autore della graphic-novel da cui è tratto la pellicola. La trama scorre come un inesorabile conto alla rovescia verso una tragedia annunciata che grava costantemente sullo spettatore, ripercorrendo fedelmente i “dolori del giovane Dahmer”; nel tentativo di decifrare tutti i segnali che presagiscono la deflagrazione della sua follia omicida: dal divorzio doloroso dei genitori, al feticismo per le carcasse degli animali morti, passando per i latenti problemi di alcolismo, fino a quelli legati ad una sessualità/socialità frustrata.
Ogni personaggio che incontriamo durante la narrazione partecipa più o meno attivamente alla “metamorfosi” di Dahmer e sceglie deliberatamente di ignorarlo, a partire dall’amico Derf (Alex Wolf) - cinico e manipolatore – l’unico che sembra provare ad empatizzare con lui inizialmente – eleggendolo come “mascotte” della scuola - per poi umiliarlo e abbandonarlo proprio nel momento di maggior bisogno, alle soglie di un destino che ormai appare irrevocabile. La particolarità che distingue ed esalta la ricostruzione filmica di Meyers è quella di saper indugiare sulle premesse morbose delle situazioni descritte – portando al limite l’attenzione dello spettatore - senza mai cedere alla tentazione di mostrare la violenza esplicita che contraddistinguerà le gesta future del suo protagonista. Durante tutto l’arco del film l’orrore – quello vero – si percepisce altrove: nei silenzi pesanti come lapidi, negli sguardi assenti e nelle grottesche performance di Dahmer, costretto a recitare la parte dello spastico pur di elemosinare le attenzioni dei sadici coetanei. Diversamente da altri biopic – incentrati su celebri serial-killer - che si perdono nella spettacolarizzazione dei fatti di cronaca, togliendo fisicità ai protagonisti e attribuendo loro identità semplificate e posticce, qui la figura di Dahmer ci viene descritta in tutta la sua complessità.
Il merito spetta sopratutto alle doti attoriali di Ross Lynch – ex star di Disney Channel - che dimostra di sapere interiorizzare perfettamente il disagio del suo personaggio, i suoi scatti d’ira imrprovvisi, la sua libidine repressa fino a incarnarne perfettamente anche ogni dettaglio fisico: dall’andatura strascicata alla postura curva e pesante che nasconde un’inettitudine di facciata che già lascia intuire una lucidità fuori dal comune. Dove altri registi - prima di lui - hanno fallito, Marc Meyers riesce nella sua missione di raccontare con il suo My Friend Dahmer la “metamorfosi” del Cannibale di Milwaukee - una storia sgradevole da romanzare – come se fosse un film “coming of age” diretto da Richard Linklater, con gli stessi colori saturi, una colonna sonora ricercata, una regia asciutta e una riflessione di fondo difficile da metabolizzare. Perché alla fine della visione, quando pensiamo di trovarci davanti il solito “mostro” da stigmatizzare , scopriamo in realtà di aver conosciuto soltanto Jeffrey Dahmer di Bath nell’Ohio, un ragazzo qualunque che sta per franare in un abisso di atrocità che forse si sarebbe potuto evitare.
Regia: Marc Meyers
Cast: Ross Lynch, Anne Heche, Alex Wolff, Dallas Roberts, Vincent Kartheiser
Durata: 107 minuti
It Follows / Oltre la linea d’ombra

«E’ privilegio della prima giovinezza vivere oltre il presente, nella bella e ininterrotta speranza che non conosce pause o introspezione»
Joseph Conrad
Con due soli film all’attivo, <i>The Myth of American Sleepover</i> (2010) e <i><b>It Follows</i></b> (2014), <b>David Robert Mitchell</b> si è affermato come uno dei registi più promettenti del nuovo cinema indipendente americano (non indie, perché dello stile ormai ammiccante e fintamente garage del filone Sundance i film di Mitchell non hanno davvero nulla).
Nonostante appartengano in apparenza a generi diversi (racconto di formazione adolescenziale il primo, slasher anni Ottanta il secondo), i suoi primi due film rivelano una forte coerenza tematica e stilistica ruotante attorno ad un unico argomento, l’adolescenza – intesa come fase di rottura nella quale timori e ossessioni e speranze perdute si manifestano ripetutamente. In questo senso <i>The Myth of American Sleepover</i> e <i>It Follows</i> sembrano essere l’uno la riscrittura dell’altro, anche se sarebbe più opportuno parlare di prosecuzione lineare. Entrambi i film infatti si concentrano sul concetto di racconto di formazione, ma se in <i>The Myth</i> l’orizzonte di passaggio è quello tra infanzia e giovinezza, <i>It Follows</i> sposta avanti di qualche anno il discorso e porta i suoi protagonisti al confine con la prima età adulta. In ambedue i casi il passaggio è traumatico e inteso nei termini della perdita: in <i>The Myth</i> vediamo adolescenti divisi tra sete di scoperta (anzitutto sessuale) e malinconia per l’infanzia perduta (il mito cui fa riferimento il titolo è quello della vita da teenager, in cui si scambia l’innocenza di un tempo per una prima libertà che genera però confusione e disagio esistenziale); <i>It Follows</i> invece sfrutta le dinamiche dell’horror per imbastire un’elaborata metafora sull’insorgere di paure mortifere e ossessioni in seguito alla scoperta del corpo sessuato, passaggio che porta ad una rottura nella continuità della rappresentazione del Sé e genera disagio in assenza di una cornice di sicurezza che sia genitoriale o sociale.
Infettata da una maledizione mortale dopo aver avuto quello che probabilmente è il suo primo rapporto sessuale, Jay sembrerebbe la perfetta protagonista di uno slasher, sotto-filone horror che ci ha abituato a vedere corpi adolescenziali straziati in seguito ad eccessi della carne. Leggere in tal senso <i>It Follows</i> però sarebbe fuorviante e limitativo. Nonostante Mitchell giochi con i canoni del genere e flirti apertamente con la dimensione cinematografico/temporale degli anni Ottanta (in modo volutamente criptico e onirico), <i>It Follows</i> non vuole essere né una parabola morale né una metafora scoperta dell’infezione sessuale. Certo, il riferimento all’HIV è lampante, tuttavia tanto il rapporto con il lavoro precedente quanto un’infinità di altri elementi sparsi da Mitchell portano il film da un’altra parte, riconducendolo ad un terreno di coming-of-age nel quale la scoperta del sesso ha lo scopo di sancire anzitutto il passaggio all’età adulta. Andando a scavare in una prospettiva più psicanalitica, <i>It Follows</i> ci ricorda come la scoperta del corpo sessuato si carichi di aspettative e significati esistenziali anche per via dell’assenza di forti riti di iniziazione collettivi nella nostra società occidentale. L’accesso all’età adulta è una mutazione ontologica che comporta rottura, strappo e ridefinizione futura, un passaggio che se non avviene all’interno di un contesto simbolico evidente rischia di creare vuoti di senso e panico e disillusione esistenziale. Dopo aver consumato il suo rapporto con Hugh, Jay parla non a caso del senso di vuoto sopraggiunto con la crescita, una mancanza di direzione che sembra rinchiuderla in un limbo all’interno del quale risulta impossibile per lei trovare la propria nuova identità. Ecco così che nella riscrittura del genere quella che era la tipica punizione dello slasher diventa una nuova ossessione e paranoia, ansia generata dall’assenza di comunità e riti evidenti.
Una figura silenziosa che procede verso di noi, lenta ma inesorabile, mentre i nostri arti restano inchiodati dove sono in attesa di un contatto che si prefigura mortale. C’è chi ha parlato di <i>It Follows</i> in termini lynchiani, un paragone che esula però la forma cinematografica e trova la sua ragion d’essere in un terreno comune: il sogno lucido. Come Lynch infatti Mitchell riesce a riportare sullo schermo quella particolare dinamica onirica all’interno della quale si diviene coscienti del proprio stato dormiente mentre una presenza oscura e mortale si avvicina inarrestabile verso di noi, fino a toccarci e a causare la nostra morte/risveglio. E’ difficile infatti non vedere una rielaborazione di questo fenomeno nello spettro di <i>It Follows</i>, del resto lo stesso Mitchell ha indicato come origine del film un sogno analogo. Nella prospettiva di formazione adolescenziale e di crisi sopra tracciata, la persecuzione ossessiva subita dallo spettro diventa allora la scoperta della propria mortalità, il sopraggiungere di tale consapevolezza che per la prima volta coglie nel profondo un ragazzo adolescente. Per Jay e il suo gruppo di amici la scoperta sessuale diventa l’ingresso in un’età adulta caratterizzata dalla perdita di controllo, dal timore per il futuro e dalla presenza inalienabile della morte nella vita. In fila al cinema assieme a Jay, Hugh si presta al gioco di indicare una persona che vorrebbe essere in quel momento, e non a caso la sua scelta ricade su un bambino piccolo, innocente ma soprattutto inconsapevole degli aspetti profondi della sua mortalità. La pulsione sessuale si rovescia e diventa ossessione per la morte, un pensiero intrusivo che come una maledizione si inocula nella mente per ripresentarsi ripetutamente nei termini della paranoia. Lo spettro di <i>It Follows</i> non è né zombie né fantasma ma una vera e propria morte vivente, che a volte assume i tratti di corpi anziani e decadenti, altre di genitori assassini. Perché è evidente come tutto questo accada in un mondo privo di adulti e figure di riferimento, un mondo all’interno del quale i ragazzi sono lasciati totalmente a loro stessi e soltanto tra di loro possono trovare la forza e il coraggio per reagire. In molti hanno giustamente sottolineato come l’avvento della maledizione sia per lo meno favorito dalla solitudine assoluta in cui vivono i ragazzi protagonisti, tuttavia l’attacco di Mitchell va più nel profondo, e ricollegandosi al decadimento urbano di una Detroit astratta sì ma molto vicina agli anni 80 diventa inequivocabilmente politico.
Quasi casualmente, tanto che è difficile coglierlo ad una prima visione, i protagonisti di <i>It Follows</i> citano la 8 mile, la celebre strada che separa i quartieri suburbani di Detroit dal centro città, luogo di decadenza e crimine e squallore, quello stesso degrado che nel corso nel film vedremo comparire più volte e che diventa sede di rifugio in diversi momenti del narrato (la casa di Hugh, la piscina). Di fronte queste immagini di abbandono e degrado urbano l’ambientazione fortemente anni 80 voluta da Mitchell non può quindi ridursi ad un discorso cinematografico ma diventa vero attacco politico ad una società (quella reaganiana) incapace di costruire un futuro per i suoi figli e di fornire strutture adeguate ad affiancarli nel loro percorso di formazione. A mancare in <i>It Follows</i> non sono soltanto i genitori ma la società tutta, specie in una città che proprio negli Ottanta ha visto crollare la propria industria automobilistica a fronte di politiche classiste e incuranti. In questi anni la cosiddetta Motor City d’America diventa la Murder City, famosa in tutto il paese per il degrado e il crimine del proprio centro urbano, al quale corrisponde una fuga in quei suburbs nei quali abitano Jay e compagni. A rendere ancor più notevole l’apparato poetico di <i>It Follows</i> è allora quest’intrecciarsi di piani metaforici diversi, una rappresentazione in cui senza soluzione di continuità si racconta di un coming-of-age la cui linea d’ombra diviene sede di mostruosità ancestrali di genesi esistenziale e politica. A fronte di quell’assenza di strutture di cui si è parlato, per questi ragazzi l’unica soluzione rimasta è allora l’accettazione, la rinuncia al combattimento come autentica via di fuga. Se il piano in piscina si rivela un fallimento è perché a poco o nulla serve combattere contro le proprie compulsioni e paranoie, è anzi quando si rinuncia a tenere lontano il demone che la paura di esso sparisce. Esorcizzare la morte dalla propria vita è impossibile e inutile, meglio allora tenersi per mano come Jay e Paul nel finale del film; assieme, uniti, consapevoli di uno spettro che fa ormai parte delle loro vite ma consci anche di come queste possano comunque proseguire. Epicuro diceva che non bisogna temere la morte perché quando ci siamo noi lei è assente e viceversa. <i>It Follows</i> ci ricorda il contrario, la morte è con noi ogni giorno, ma l’unico modo per non soccombere al terrore è smettere di combatterla e continuare a camminare. Magari assieme.