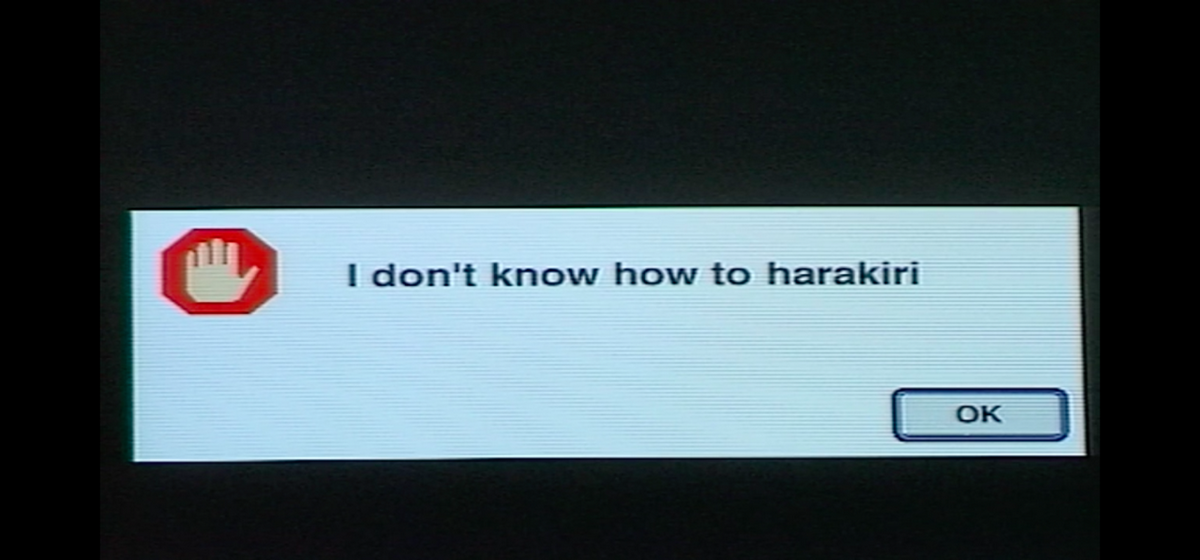L’età inquieta

Festival di Cannes, 1997. Mentre Michael Haneke presenta in concorso Funny Games e Wong Kar-wai arriva sulla Croisette con Happy Together, i capodopera di due orientali vincono insieme la Palma d’oro: la giuria di Isabelle Adjani premia ex aequo L’anguilla di Shōhei Imamura e Il sapore della ciliegia di Abbas Kiarostami. Siamo nel cinema di fine millennio: a cavallo tra i secoli alcuni cineasti maturi ottengono la consacrazione e nuovi autori si affermano nei rispettivi linguaggi, dallo sguardo clinico hanekiano al magistero di Wong ormai definito. Ma in quel festival accade anche un altro evento, lontano dai riflettori principali, in uno spazio periferico: un certo Bruno Dumont presenta il suo esordio al lungometraggio, La vie de Jésus, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Vincerà la Caméra d’or come menzione speciale. Il film uscirà in Italia con il titolo L’età inquieta, forse parafrasando L’età acerba, titolo affibbiato tre anni prima a Les roseaux sauvages di André Téchiné.
Quando approda alla kermesse Bruno Dumont è un ex insegnante di filosofia nato a Bailleul, nella Francia del Nord, che lavora principalmente in Belgio: ha già girato due cortometraggi come apprendistato prima di passare al lungo. Malgrado la formazione filosofica ha sviluppato un pensiero radicalmente anti-intellettuale: rifiuta il cervello e l’arzigogolo, crede nella necessità di mostrare. Ama la pittura, quella fiamminga a lui vicina ma non solo, spesso la riversa nei suoi titoli: ne L’umanità si spingerà a ricreare sullo schermo L’origine del mondo di Gustave Courbet. È innamorato di Robert Bresson: l’autore de Il diavolo probabilmente sarà sempre la sua stella polare, e lo si afferma non a caso citando il capolavoro del 1977 con il profondo nichilismo del protagonista interpretato da Antoine Monnier, una figura che respinge il mondo e sceglie la chiusura, fantasma che infesta trasversalmente il cinema dumontiano. Anche se l’archetipo bressoniano - e prima dreyeriano - che più riguarda Dumont è quello di Giovanna D’Arco, che il cineasta arriverà a rifare in un dittico. Prima di lui, in realtà, c’era stato un altro regista post-bressoniano con cui lo stesso Dumont dialoga: Maurice Pialat. Basti fare un esperimento: si vedano in sequenza Diario di un curato di campagna (Bresson), Sotto il sole di Satana (Pialat) e Hadewijch (Dumont) ragionando sulla linea che va dalla fede alla sua deformazione, dal credere al suo contrario fino al germogliare del Male con la maiuscola, nascosto dietro al quotidiano - e all’immagine - pronto a mettere radici. Oppure si confrontino due poliziotti: il Pharaon de L’umanità di Dumont, secondo lungometraggio del ’99 che del primo è diretta evoluzione, e il poliziotto Margin incarnato da Depardieu in Police (Pialat, 1985), entrambi invischiati in quel Male a cui di fatto partecipano.
Al centro de La vie de Jésus c’è Freddy (l’attore non professionista David Douche, come tutti), giovane epilettico che vive in un paesino delle Fiandre. La sua vita scorre in una grigia quotidianità tra gli amici, le corse in motorino e la ragazza Marie (Marjorie Cottreel), che fa la cassiera in un supermercato. Spesso fanno sesso o si baciano davanti agli altri, ma il loro è un gesto meccanico, senza amore né passione, pura ginnastica. La routine si inceppa quando nel piccolo centro arriva Kader (Kader Chaatouf), un ragazzo di origine magrebina che cerca di avvicinarsi proprio a Marie... Perché questa storia di provincia si chiama La vita di Gesù? Dumont sceglie un titolo evocativo, anti-narrativo, chiamando in causa lo spettatore e convocandolo all’interpretazione: nella prima parte del racconto, a un certo punto, gli amici si recano in ospedale per visitare un loro compagno che sta morendo di Aids (e torna ancora Pialat: rivedere La gueule ouverte, 1974). Sul muro c’è una copia de La resurrezione di Lazzaro di Giotto, che suona antifrastica rispetto alla condizione, perché la figura che vediamo morente non risorgerà. Dietro alla superficie da subito comincia a insinuarsi qualcosa, un umore strisciante che vive sotto il velo dell’immagine e gradualmente viene alla luce.

«L’idea è quella di filmare il Male, di dargli una forma - dice Dumont - : ma che cos’è il Male? È filmare un uomo: raccontare una storia cercando di portar fuori il Male, facendolo uscire dall’interno di tutti gli spettatori». In questo processo maieutico la sostanza di cui il regista si nutre ha un nome preciso: xenofobia. Il razzismo tacitamente si affaccia nella mera esistenza dei ragazzi, nel loro tirare a campare: non si tratta però di un odio esplicito o spiegato, neanche di un sentimento, ma di un istinto lontano anni luce da ogni sociologismo, un raptus, uno “scatto” iscritto nella loro natura degradata e quindi nello statuto precario dell’essere umano. «Sgozziamoli tutti», dice Freddy parlando dei migranti arabi, e lo dice con leggerezza, ridendo, in uno scherzo tra amici. Senza motivo. Forse per noia, automaticamente: allo stesso modo con cui gli adolescenti eseguono le prove della banda musicale, senza particolare adesione, come gusci vuoti. È così che si forma la repulsione verso l’altro, il diverso, il distante da noi, un rifiuto che imbocca il percorso naturalmente indirizzato verso la tragedia.
Ma, come detto, in Dumont nulla viene detto. Tutto è davanti agli occhi. Per suggerire la vera essenza dei suoi personaggi l’autore si affida a un elemento preciso: il paesaggio. «La ripresa dei paesaggi nel mio cinema non ha niente a che vedere con il reale (...): penso che sia espressione di un’interiorità. Quando filmo un paesaggio sto filmando l’interiorità del personaggio» (conversazione con Bruno Dumont di Enrico Lo Coco e Marco Grifò, Lo Specchio Scuro, 7 aprile 2018). Le Fiandre sono per l’autore un luogo dell’anima, uno state of mind. Daranno il titolo al suo film del 2006, Flandres. Sono come le Ardenne per Fabrice du Welz, ma in modo diverso: Dumont fa dialogare il paesaggio con il personaggio attraverso l’inquadratura. Tra piani fissi, profondità di campo e lenti movimenti di macchina Freddy e i suoi amici si riflettono nello sfondo fiammingo brullo e desolato, come in un quadro di Pieter Bruegel. Questo serve a suggerire l’intimo delle loro figure e a innescare il processo di “estrazione” dallo spettatore: solo osservando attentamente l’esterno si capisce veramente chi sono. La quintessenza della strategia, ne L’età inquieta, avviene nel finale quando Freddy si sdraia a terra dopo il delitto, entrando in contatto fisico col terreno, ricongiungendosi così matericamente alla propria ferinità. Il controcampo offerto dal movimento di macchina dumontiano è una veduta del paesaggio belga: l’erba mossa dal vento, il cielo nuvoloso. L’uomo è anche, soprattutto, animale.
L’età inquieta ha spaccato il cinema di fine anni Novanta. Con forza ha proposto un nuovo autore radicale, francescano “dalla parte sbagliata”, ovvero provocatorio, rigoroso, a suo modo puro perché capace di creare senso solo attraverso l’immagine. Di portare avanti la lezione di Bresson. È l’inizio di un talento poi diventato aggettivo: di un certo cinema oggi si dice “dumontiano”, per esempio il tedesco Philip Gröning, quello de La moglie del poliziotto e soprattutto dell’inedito My Brother’s Name is Robert and He is an Idiot, è un regista dumontiano. Adesso, quasi venticinque anni dopo, questo titolo resta una testimonianza del primo Dumont, il più inflessibile e spietato, prima che nei nostri anni prenda un percorso diverso, forzando la virgola che separa il tragico dal comico e il dramma dalla farsa (si pensi a Ma Loute o la serie P’tit Quinquin). All’epoca si leggeva la sorpresa in filigrana anche nei Cahiers du cinéma: «Ecco un bellissimo film a forma di imbuto (...). Una forma che diventa affascinante quando, come ne L’Argent, la narrazione si stringe e passa dall’aneddotico all’improbabile per finire nella cronaca: un giovane ne uccide un altro. Un omicidio così logico, di una logica così semplice, che paradossalmente sembra accadere per caso» (Thierry Lounas, giugno 1997).
L’esordio di Dumont chiude il Novecento e anticipa il razzismo del nuovo millennio, le aggressioni per noia, le rivolte nelle banlieue, insomma i segni del grande Male contemporaneo: ma resta soprattutto la nascita di uno dei maggiori registi di oggi, autore di un cinema tanto cristallino quanto scomodo, tanto ineffabile quanto sconcertante, perché con l’immagine mette l’anima allo specchio.