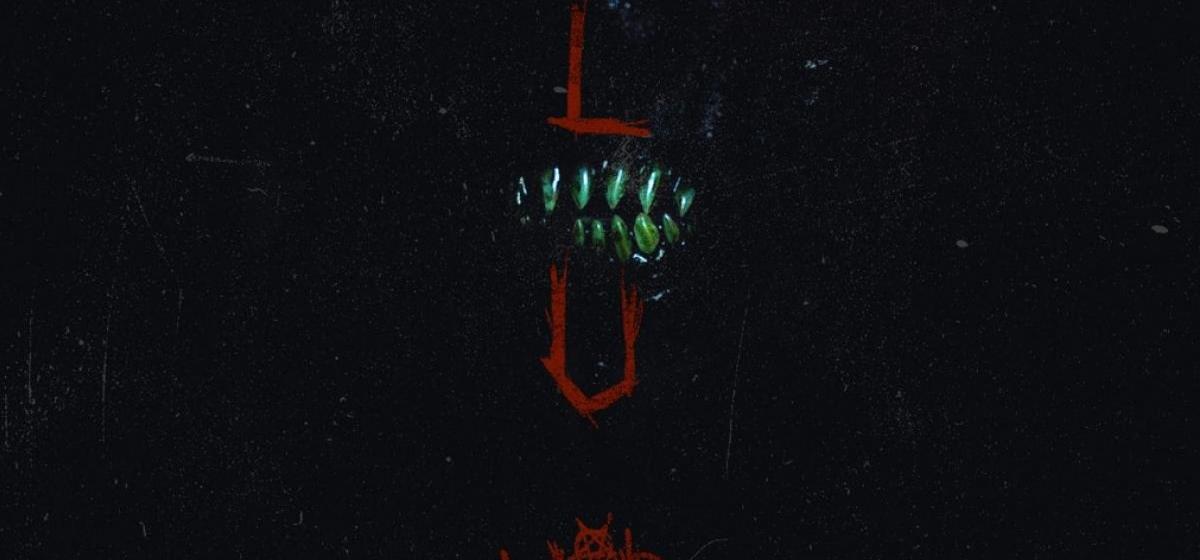Cobweb

"Nessuno saprà mai se i bambini sono mostri, o se i mostri sono bambini. "
Non si tratta di una citazione casuale quella con cui Lucio Fulci conclude il suo Quella villa accanto al cimitero: un affresco malinconico, spettrale e anticonformista sulla dimensione illogica dell'infanzia dove si rintanano nel buio della psiche entità spaventose, impulsi omicidi e morbose fantasie di vendetta. Nel 1981 il colto regista romano aveva già percepito come la riflessione di Henry James estrapolata dal celebre romanzo Giro di vite, pietra angolare del genere gotico, fosse l'unica chiave di lettura possibile per comprendere e rappresentare compiutamente la vastità e la complessità dell'universo infantile in tutte le sue sfaccettature. L'influenza dell' intuizione visionaria di James, come quella dell'opera di Fulci, si riverbera ancora oggi su tutto il cinema fantastico - soprattutto in ambito horror - laddove un autore scelga di confrontarsi con gli orrori dell'infanzia per interrogarsi sul rapporto simbiotico (e simbolico) che intercorre tra innocenza e mostruosità.

Nel corso degli anni il grande schermo è stato letteralmente invaso da una covata malefica di piccoli animi corrotti - sulle orme tracciate dai bambini innocenti di Clayton e quelli dannati di Rilla - in grado di compiere e di assistere inermi a qualsiasi genere di efferatezze malgrado la presunta innocenza che li dovrebbe contraddistinguere; di solito si tratta di ritratti archetipici dove la sfera infantile e preadolescenziale diventa automaticamente sinonimo di abbandono, marginalità e morte. Lo testimoniano, in tempi recenti, sia i giovani protagonisti dell'osannato film australiano Talk to Me diretto dalla coppia di youtuber Danny e Michael Philippou, sia i bambini spaesati dello sperimentale Skinamarink di Kyle Edward Ball. Nonostante le presenze fantasmatiche rappresentino l'elemento visivo predominante di queste opere, il ruolo dei bambini resta centrale all'interno della narrazione in quanto essi condividono la stessa dimensione di alterità e solitudine dei mostri (interiori) che li perseguitano e li opprimono. L'incomunicabilità di questa condizione si trasforma così in un "catalizzatore naturale" di eventi sinistri, surreali e insidiosi che si manifestano puntualmente lontano dallo sguardo offuscato degli adulti.

Questo aspetto risulta ancora più evidente se analizziamo il recente Cobweb: una fiaba nera a tutti gli effetti - vicina alle atmosfere di Babadook - dove quel gomitolo confuso di timori e ossessioni tipiche dell'infanzia prende forma grazie alla sensibilità del regista francese Samuel Bodin. Come molti dei suoi coetanei, anche il protagonista di questa storia - il timido Peter - è un bambino introverso, bullizzato dai coetanei e incompreso dai genitori, che trova conforto soltanto tra le ombre del suo isolamento forzato. Nella sua giovane esistenza l'unica presenza capace di comprenderlo, ma soprattutto di difenderlo dalla angherie e dalla nevrosi del mondo esterno - oltre ad una premurosa insegnante - sembra appartenere a una forza misteriosa che alberga tra le mura della sua abitazione in attesa di essere sprigionata. Ignorato da tutti, nonostante le disperate richieste d'aiuto, recluso nel microcosmo provinciale della sua casa/prigione, il bambino, stanco di subire, sfogherà ben presto la sua frustrazione con inaudita violenza, scoprendo troppo tardi - insieme agli spettatori - la natura ostile del male che ha liberato e che sta per inghiottirlo.

Dopo l'avvincente serie horror Marianne targata Netflix, Samuel Bodin torna di nuovo dietro la macchina da presa per raccontare, in modo altrettanto intelligente, una storia palpitante di incubi domestici e fratture familiari alimentata e sostenuta da un senso del ritmo formidabile, un intreccio narrativo affascinante e una recitazione sopra la righe. Fin dal principio la scelta del cast risulta particolarmente appropriata, soprattutto per quanto riguarda il bizzarro connubio tra Lizzy Caplan e Antony Starr nei panni di una bizzarra coppia di genitori psicotici, protagonista di alcuni dei momenti più deliranti del pellicola. Nota di merito anche per la figura del bambino, interpretato da Woody Norman, che si rivela il motore dell'azione, la causa sconvolgente degli eventi, demolendo la convenzione universale che lo vorrebbe relegato al ruolo di puro spettatore inconsapevole. Contrariamente ad altre pellicole, il film di Bodin non tenta infatti di giustificare l'infanzia, anzi la mette in discussione svelandoci il mostro che si nasconde sotto il letto, la "metà oscura" dei bambini: quella dionisiaca, emotiva, nichilista e in quanto tale votata alla distruzione. Al netto di alcune incongruenze riscontrate nella sceneggiatura, il pregio maggiore di questo lavoro, a dispetto di molte produzioni contemporanee, resta quello di "credere fermamente nella potenza evocativa del cinema di genere puro e semplice" (Calzoni).

Da questo punto di vista Bodin è consapevole che non ha bisogno di "elevare" il suo film con pedanti allegorie per renderlo credibile, memore della lezione di Stephen King secondo cui "un sottotesto funziona a meraviglia soltanto se non è invadente". Infatti, quello che ci viene presentato in Cobweb è un orrore fiabesco dalle regole semplici e brutali come sono semplici e brutali certi giochi dei bambini: la quintessenza della narrativa del brivido. Il tipico racconto di mezzanotte dal sapore autunnale, ricco di dettagli sanguinolenti e situazioni angoscianti, che progredisce inesorabile e scava sottopelle, costruendo un clima di terrore latente per poi deflagrare (e deragliare) in un finale esplosivo. La resa dei conti conclusiva tra Peter e il suo alter ego maligno probabilmente è l'elemento più grossolano e discutibile del film ma non riesce comunque a cancellare nello spettatore quella sottile sensazione di disagio provocata così abilmente durante il resto della visione. Un risultato che non può lasciare indifferenti, perché dimostra come sia ancora possibile arrivare al cuore del pubblico affidandosi a un linguaggio autoriale "primitivo" ed efficace - privo di inflessioni hipster - capace di spaventare senza dover per forza ostentare.