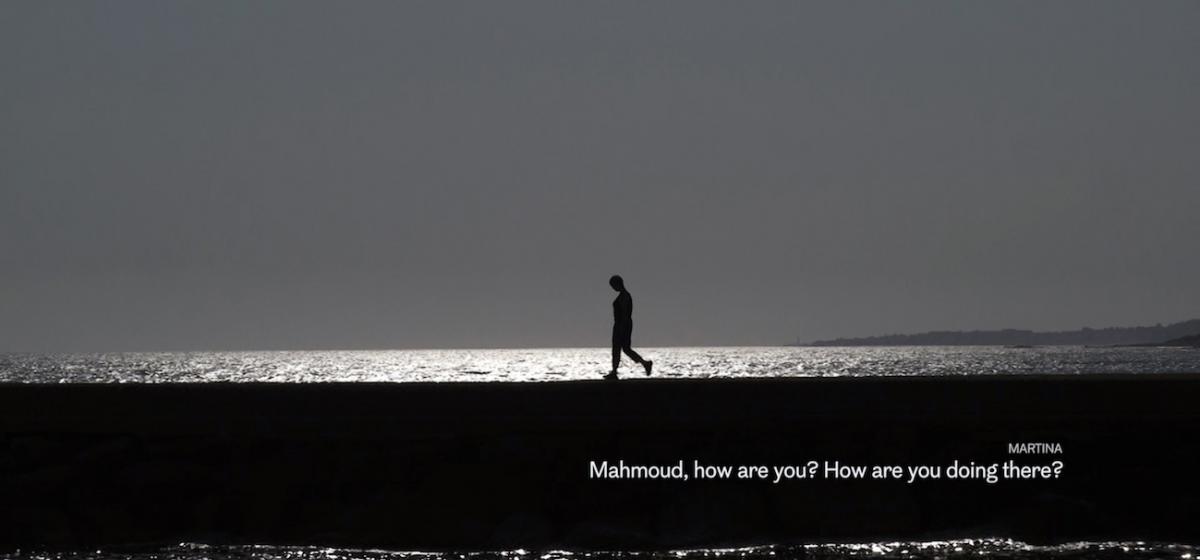Fahrenheit 451

Fare cinema significa spesso impaginare, visualizzare un’idea di mondo. Nel perimetro espressivo di un certo cinema di genere (e in particolare di un certo tipo di fantascienza distopica), tuttavia, fare cinema significa anche e soprattutto immaginare un’idea di mondo: formulare geometrie (politiche, sociali ed economiche) dotate di carica finzionale di sussistente credibilità, fare world building narrativo all’interno del piano regolatore della sospensione dell’incredulità e quindi pensare architetture narrative coordinate per formare grandi e “completi” complessi architettonici. Non è un caso che molte delle produzioni di genere fantascientifico abbiano disatteso ambizioni contenutistiche proprio per colpa di basilari difetti strutturali. Quest’ultimo adattamento cinematografico di Fahrenheit 451 prodotto da HBO Films non è che l’ultima prova di ciò che succede a una narrativa cinematografica di fantascienza quando tutte le forze creative sono tese alla costruzione di un impianto d’ambientazione dettagliato e questo impianto non si dimostra abbastanza solido per reggere il peso di una minima crepa di senso, capace di allargarsi divorando l’edificio intero.
Nel caso del film diretto Ramin Bahrani (che firma la sceneggiatura assieme ad Amir Naderi, come già fatto per il più riuscito 99 Homes) il problema risiede nell’assenza di credibilità insita in due scelte di base: raccontare e ricreare nei dettagli il mondo immaginato nel 1953 da Ray Bradbury, trasportandolo però in un futuro prossimo rispetto ai nostri giorni, e allo stesso tempo ignorare le modifiche apportate dalla contemporaneità ai media protagonisti della narrazione originale. Il film soffre sia perché non riesce a comprimere in un minutaggio contenuto un immaginario dal respiro molto ampio, sia perché aggiorna cronologicamente questo immaginario senza tenere conto delle evoluzioni del presente: la tecnologia ha da molto superato l’immaginazione contenuta in un certo tipo di fantascienza, la realtà ha doppiato la finzione con l’agilità e l’inventiva di un’innovazione tecnologica che, invece di portare all’eliminazione fisica dei libri in favore dei mass media, ha trasformato il fuoco distruttore in elettricità eco-friendly, l’incendio delle salamandre in cortocircuito su schermo, il divampare spigoloso delle tirannie in un contatto digitale liquido, morbido e apparentemente innocuo.
Troncato da un format incongruente con la complessità “cosmologica” desiderata, e distorto dal ridimensionamento della lungimiranza profetica della fantascienza ad opera del cambio dei supporti (da cartacei a digitali) e della loro fruizione, Fahrenheit 451 impiega così molte delle sue cartucce (e metà del suo minutaggio) per presentarci una realtà che smette di essere interessante fin dai primi minuti. Il palco di una Cleveland fatta di grattacieli con proiezioni interattive dominata da un inedito social dal controllo totale (chiamato The Nine) non è che un fondale derivativo, un arredamento di maniera; l’azione narrativa gira invece a vuoto, lungo un arco esplorativo che trova nei grandangoli a 360° e nella descrizione dei device distopici i canali per ottenere la tridimensionalità del quadro generale ma non delle individualità caratteriali dei personaggi: la somma delle due cose è un risultato dannoso e qualitativamente insufficiente che punta tutto su atmosfere ormai normalizzate (dalla realtà, oltre che da racconti precedenti e più brillanti) e niente sul vero nucleo tematico: l’importanza della parola, della scelta, del libero pensiero, di quella attività intellettuale eterogenea che è fuoco che combatte fuoco.
La debolezza contenutistica di un mondo inventato che nell’allineamento con la contemporaneità perde fascino e forza espressiva, acquistando un paradossale anacronismo è la ecisiva per il crollo di un sistema strutturale immaginato con pietre angolari deformi. Crollo dopo cui non rimane niente: nessuna valida psicologia dei personaggi, nessun percorso narrativo forte, nessuna tematica importante. Imprigionati in un mondo senza storia e appiattiti su un racconto poco chiaro nelle svolte e nei messaggi, i protagonisti – a cui neanche gli attori (Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella) riescono a dare peso – si dimostrano automi che agiscono secondo intenzioni monodimensionali e non alfieri di una rivoluzione contro il potere dei mass media e dell’ignoranza controllata, non il perno di una narrazione umanistica e ribelle.
Mangiato da ambizioni fuori misura e reso piccolo come la fiamma di un fiammifero, Fahrenheit 451 risulta così annullato da sé stesso, svuotato dalle sue intenzioni costruttive fino al punto da perdere anche qualsiasi carica emotiva o patrimonio concettuale che poteva ereditare dal capolavoro da cui è tratto. Alla fine niente di più che un prodotto dimenticabile in cui non si salva nulla, se non la voglia di recuperare in fretta la sua versione letteraria originale.